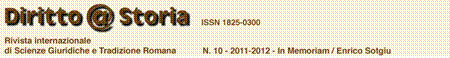PER ENRICO … E PER NOI TUTTI
Presidente
Emerito della Corte Costituzionale
Mi hai chiesto, Lalla, di dire qualche parola del tuo e nostro
Enrico, nel momento in cui ci raccogliamo per ricordarlo e, per così dire, lo
facciamo rivivere nell’unico modo in cui ci è possibile, cioè riproponendolo
alla nostra memoria, che è cosa del passato, e al nostro affetto, che è invece
cosa del presente e, se ce ne sarà dato il tempo, del futuro. Hai aggiunto che
forse, anzi qualcosa di più che “forse”, questo sarebbe stato anche desiderio
di Enrico. Ma, avendo detto di sì senza esitazione, anzi con gratitudine, mi
trovo ora a confessare ch’io conoscevo poco di lui, in ogni caso meno di quel
che il molto dolore per non averlo più mi faceva presumere di conoscere. Forse
ciascuno di noi ha qualcosa di misterioso per gli altri. Questo, ora che ci rifletto,
era Enrico per me: misterioso al di là dell’apparenza, ma non per questo meno,
anzi più caro; non meno, ma più importante.
Da dove viene questo senso di vuoto, questa sensazione che un pezzo
importante, tra i pezzi che gli altri rappresentano nel mosaico della vita, non
c’è più? In breve, che cosa ci è venuto a mancare? Che cosa è ciò che riempiva
quello che ora è vuoto?
Detto così, è chiaro che la risposta non può venire da altri che da
ciascuno di noi, e può essere diversa da uno a un altro. Nella risposta, ci
scopriamo e riflettiamo noi stessi, perché dichiariamo ciò che per noi è più,
meno, per nulla importante. Così è sempre, di fronte alla morte di qualcuno con
il quale, insieme, si siano trascorse parti della nostra vita, quando sai che
non ce ne saranno altre.
Quali parti? Innanzitutto, la Sassari universitaria degli anni
settanta. “Innanzi tutto”, perché è stato non solo l’inizio, ma anche il
periodo più importante della nostra formazione. Guardando a quel tempo a
distanza d’ormai più di quarant’anni, non si può evitare qualche cedimento
all’idealizzazione d’un tempo che certamente è stato difficile per il nostro
Paese, anzi drammatico, ma per noi è stato pieno di vita, perfino felice, pur
se allora non ce ne rendevamo pienamente conto. Ora che uno di noi, che di quel
tempo è stato parte importante, non c’è più, è inevitabile essere invasi da un
sentimento di malinconia, sol che ci volgiamo indietro e ci concentriamo a
rievocare ciò che siamo stati e non siamo più.
Parlo al plurale, come avrete notato, perché mi riesce impossibile
considerare Enrico un “a parte” staccandolo, quasi amputandolo da ciò che è
stato un momento d’intensa vita in comune tra molti che, in quegli anni, sono
passati per le Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche (all’inizio, la
seconda era parte della prima) di questo Ateneo. La casa di Via Enrico Costa è
stata un punto d’incontro e di allegria, per diversi periodi anche di
stazionamento, alloggiamento e nutrimento, nei due appartamenti, il loro e
quello al piano superiore, che “i Sotgiu” con perfetta e generosa naturalezza e
libertà mettevano a disposizione di noi forestieri. E poi la casa di Tempio,
grigia e accogliente, in particolare in un dicembre nevoso che mi sembrava
trasportare fuori del tempo. Se non “la meglio gioventù”, abbiamo la sensazione
che quella sia stata per noi, almeno, una buona gioventù.
Che cosa era la nostra Università? Forse lo sguardo retrospettivo
m’induce a idealizzare. Può essere. Ma non ricordo altro periodo, in un’ormai
lunga vita accademica, così vivo e appassionato per le questioni comuni, e
anche così conflittuale. Sì: conflittuale, ma il più delle volte non per
meschine questioni personali, familistiche o di clan accademico, ma per ragioni
di natura generale che riguardavano la concezione della vita universitaria, la
collocazione dell’Università nella città e nella Regione, l’apertura al mondo
(ricordate, la politica d’accoglienza, in quegli anni, nei confronti dei
fuoriusciti cileni?). Erano dunque conflitti vitali, molto diversi da quelli
puramente politici o di piccolo potere che tanto spesso corrompono il
significato dell’autonomia universitaria. Onde, ancora oggi, incontrandoci tra
noi, qui o altrove, per quanto allora si fosse su posizioni diverse, si avverte
con nostalgia di avere avuto qualcosa in comune. L’essere allora stati
sassaresi è ancora oggi un segno distintivo.
I pre-Consigli di facoltà che duravano giornate intere, le lezioni
sulla piazza, i tentativi di rapporto con La
nuova Sardegna sotto il controllo di nostri studenti – alcuni dei quali ora
colleghi – che ci ricordavano che non si scrive per noi ma per quelli che ci
leggono, le conferenze di facoltà proposte alla cittadinanza, la vitella e il
circuito di commercio alternativo, il “rapporto col territorio”, la musica, e
tante altre cose che meriterebbero d’essere censite perché se ne conservi
memoria: tutto questo accanto all’attività accademica tradizionale, rinnovata
da un certo modo di far lezione, in dialogo tra noi professori. Insomma, si
credeva in un non impossibile rinnovamento, a partire da quel che una comunità
universitaria poteva fare. Era una comunità vivissima, di giovani professori
che per la prima volta si trovavano a respirare aria di libertà, affrancati
dalle gerarchie accademiche delle loro sedi di provenienza; una comunità che,
pur nella diversità delle posizioni, giustificava passioni, conflitti e
innovazioni che oggi sembrano appartenere a un’altra epoca, quando a una minore
autonomia istituzionale corrispondeva una maggiore energia rinnovatrice.
Enrico si era laureato con Pierangelo Garegnani. La tesi era di
storia economica. Si era spostato poi con Mattia Persiani al diritto del
lavoro, materia che iniziò a insegnare quando Persiani stesso lasciò l’Ateneo
sassarese. Altri, competenti, parleranno della sua attività di giulavorista.
Entrambe le scelte – la tesi sulle riforme agrarie nel Mezzogiorno e il diritto
del lavoro – testimoniano di un atteggiamento engagé. Ma di che tipo? Il contesto gli era favorevole, ma l’atteggiamento
di Enrico era di tipo particolare. Era con gli altri, ma anche un poco no.
C’era in lui come uno sguardo da una certa distanza, che si manifestava in
allegra ironia e autoironia, in un non prendere sé e gli altri troppo sul
serio. I problemi sono seri e gravi, ma i problemi, appunto: attenzione a non
scambiare noi stessi, con i problemi. L’ironia, che si manifestava spesso in
commenti fulminanti e battute irresistibili – ai Consigli di Facoltà, o alle
conferenze in quest’Aula Magna, era consigliabile non essere seduti accanto a
lui: il contegno poteva soffrirne – non era mai segnata da acrimonia. Metteva
in luce, per così dire, l’altro lato di quello che noi siamo, quello che ci
induce, se non lo teniamo sotto controllo, a mettere noi stessi davanti alle
cose, davanti ai problemi: in altri termini, a fare di noi stessi l’oggetto
dell’attenzione. I tronfi, i sicuri e soddisfatti di sé, spesso senza motivo,
erano i suoi bersagli. Insomma, guardare le cose nelle giuste proporzioni e non
alterarle, le giuste proporzioni, soprattutto se ci siamo noi di mezzo. C’è
episodio che desidero citare, anche se mi riguarda. Mi scuserete per questo. Se
lo ricordo è perché mi pare rappresenti il suo modo – suo e di Lalla – di
vedere l’amicizia, le ambizioni personali (accademiche, in questo caso) in un
vero rapporto d’affetto. Accadde, a un certo punto, che mi si prospettasse la
possibilità d’essere eletto Preside di Facoltà. Enrico non poteva essere
contrario e difatti non mi disse d’esserlo e certamente mi diede il suo voto.
Però… Però, forse non mi considerava adatto; forse pensava che si trattasse
d’un cedimento a una piccola ambizione; forse riteneva che mi sarei cacciato in
molti guai burocratici. E quindi, il dì della sconfitta – la sera della
sconfitta – si trasformò in casa Sotgiu in un bellissimo, allegrissimo e molto
spiritoso festeggiamento. Che cosa c’era da festeggiare? Chiunque altro avrebbe
pensato ovviamente non a un festeggiamento ma a qualcosa di simile a una
consolazione. Ma, sarebbe stato uno stare troppo attaccati alla cosa. Non
sarebbe stata cosa congrua all’imperativo di prendere sul serio la presidenza,
ma non altrettanto il Preside.
Enrico era ammalato. Fin da quando l’abbiamo conosciuto in
Università era ammalato. Noi non sappiamo quanto questa circostanza abbia
influito sulla sua vita, sul suo atteggiamento verso la vita. Si ha un bel dire
che per tutti l’esistenza è precaria, appesa a un filo che non è nelle nostre
mani. Ma è molto diverso se c’è qualcosa che portiamo in noi e che ogni giorno
ce lo ricorda come un compagno di viaggio dal quale non possiamo staccarci.
Nessuno di noi, se non ce lo avessero detto, l’avrebbero sospettato. Se c’era
tra noi qualcuno di allegro, solare, cordiale, questi era Enrico. Non ricordo
una sola recriminazione, un solo atto di ribellione; meno che mai una
lamentazione. Forse, la sua non comune vitalità è stata come una compensazione.
I cardiopatici sono spesso così: assetati di vita, finché è possibile e, al
tempo stesso, dolcemente abbandonati a quel che la vita può riservare loro da
un momento all’altro, con un sentimento di rassegnazione a quel che è più forte
di noi.
Non so se sto tentando di costruire arbitrariamente una figura e di
attribuirla a Enrico, e così di costruire un tipo, in cui farlo rientrare.
Tuttavia, questa voglia di vita e, al contempo, questo senso della precarietà,
si incanalavano in un acuto senso della natura, grande e impassibile, e di
assorbimento nelle sue forze soverchianti. Molti dei presenti l’avranno sentito
parlare, per quanto sobriamente, delle grandi veleggiate, dei capelli e della
pelle asciugati dal sole, dal sale e dal vento; dell’appagamento d’una giornata
passata sul mare così; delle spiagge della Maddalena; delle traversate notturne
e del turno al timone sulla scia della luna piena, sempre quella, che la
navigazione fosse tranquilla o si rischiasse il naufragio. Mano a mano che il
tempo passava, la vela, troppo faticosa, lasciava il posto al motore. Il mare,
credo, è stata la sua grande passione. Immagino il peso della rinuncia, quando
nemmeno più la barca a motore fu più alla sua portata. Negli ultimi anni, lui e
Lalla aprirono una piccola casa a Parigi: aprirono in senso proprio, perché era
aperta alle persone amiche, proprio come prima era stata Via Enrico Costa. Lì,
vi ho visti l’ultima volta insieme, qualche mese fa. Enrico era affaticato, ma
non credo più preoccupato del solito. Il solito Enrico.
Ora che non c’è più e mi ritorna in mente quell’immagine della
barca che naviga nella notte sotto la luna e mi chiedo: che se ne rendesse
conto o no, Enrico era uno spirito leopardiano? Lasciatemi terminare questo
breve ricordo di lui con accenno che non è letterario nel senso corrente della
parola, ma riguarda la sua umanità come solo con l’aiuto della letteratura possiamo
tentare di esplorare. Mi immagino la sua reazione: che dici mai? Non è
questione che mi sia mai posto, e non m’interessa se lo sono o non lo sono.
Invece, poniamocela noi. La risposta mi pare debba essere duplice: no e sì.
No, non era leopardiano. La natura, il mare e la luna sopra il mare
erano per lui non la somma delle forze crudeli che alla fine ci inghiottono,
impassibili dinnanzi al nostro dolore. Era piuttosto il tutto che ci accoglie
per confondersi con noi e noi con lui. Così comprendiamo non come un moto solo
romantico la sua volontà di disperdersi ora nel mare, ma come il desiderio di
un ricongiungimento in cui trovare la pace. Come l’approdo.
Sì, era leopardiano, con riguardo all’amicizia, un sentimento che
Enrico sentiva nel profondo, forse come linimento della precarietà della sua
esistenza. Non so se avesse presente quel che, nelle Operette morali, Plotino dice al suo amico Porfirio, stanco di
vita. Permettete ch’io legga il passo finale del dialogo: “Viviamo, Porfirio
mio, e confortiamoci insieme: non ricusiamo di portare quella parte che il
destino ci ha stabilita, dei mali della nostra specie. Si bene attendiamo a
tenerci compagnia l'un l'altro; e andiamoci incoraggiando, e dando mano e
soccorso scambievolmente; per compiere nel miglior modo questa fatica della
vita. La quale senza alcun fallo sarà breve. E quando la morte verrà, allora
non ci dorremo: e anche in quell'ultimo tempo gli amici e i compagni ci
conforteranno: e ci rallegrerà il pensiero che, poi che saremo spenti, essi
molte volte ci ricorderanno, e ci ameranno ancora”.
Ecco, il senso dell’amicizia: molte volte lo ricorderemo e lo
ameremo ancora perché ci è stato carissimo e, a nostra volta, speriamo che ci
sia poi qualcuno che ci ricordi e ci ami, come noi lui.