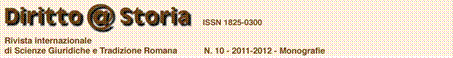Cap. III Parte III della
monografia: Omar Chessa,
Il Presidente della Repubblica
parlamentare. Un’interpretazione della forma di governo italiana, [Università degli Studi di Sassari. Pubblicazioni del
Dipartimento di Scienze Giuridiche, 17]
Napoli, Jovene Editore, 2010, pp. X-250. ISBN 88-243-1992-0

Università di Sassari
La
classificazione delle forme di governo e la “terza via” della
Repubblica parlamentare italiana
Sommario: 1. L’essenza
dualistica del regime parlamentare nel pensiero di Robert Redslob. –
2. …e nel pensiero di Georges Burdeau.
– 3. Segue: l’abbaglio del dualismo collaborativo.
– 4. L’equilibrio del
regime parlamentare tra identità
e rappresentanza nel pensiero di Carl
Schmitt. – 5. Segue: i
«sottosistemi» del regime parlamentare e l’unicità del
rappresentante sovrano. – 6. Il
monismo necessario nel pensiero di Costantino Mortati. – 7. L’alternativa tra monismo e
dualismo come criterio di classificazione delle forme di governo. –
8. Segue: i sottotipi formale e sostanziale.
– 9. Chiasmi e incentivi. – 10.
Applicazione I. La forma di governo
della Quinta Repubblica francese. – 11. Applicazione
II. La forma di governo delle regioni italiane. – 12. Il monismo nel parlamentarismo razionalizzato.
– 13. La “terza via” della
Repubblica parlamentare italiana.
1. – L’essenza
dualistica del regime parlamentare nel pensiero di Robert Redslob
All’indomani della prima guerra mondiale e in occasione della prima ondata di costituzioni razionalizzate, la dottrina europea discusse parecchio su quale fosse l’essenza più autentica del regime parlamentare.
Sulla scia della descrizione montesquieiana del modello costituzionale britannico, la dottrina ottocentesca aveva rappresentato il governo parlamentare come un sistema basato sull’equilibrio armonico dei centri di forza politica[1]. Nella prima metà del XX secolo Robert Redslob e Georges Burdeau ripropongono un analogo schema interpretativo.
Redslob muove dall’assunto che ogni costituzione abbia un «principe de vie» o «force vitale», che dà impulso all’organismo costituzionale complessivo, regolandone il funzionamento armonico. Questo principio o forza vitale riguarda soprattutto il modo in cui i poteri legislativo ed esecutivo agiscono l’uno sull’altro e nel regime parlamentare assicura che tra essi s’istituisca una condizione d’equilibrio e un legame d’interdipendenza reciproca[2]. In che modo?
Per rispondere alla domanda bisogna tenere conto degli altri due ingredienti fondamentali del regime parlamentare: il popolo e il capo dello stato. Il primo opera in modo intermittente, facendo udire la sua voce quando occorre risolvere il dissidio irrimediabile tra esecutivo e legislativo[3]. Ma è il secondo la vera «forza generatrice del meccanismo (parlamentare)»: è al capo dello stato, infatti, che spetta – in quanto «instrument de la souverainetè populaire» – il compito di disporre l’appello al popolo, mediando perciò tra il corpo elettorale, da una parte, e il parlamento e il governo, dall’altra. E così il potere intermittente del popolo si attiva su iniziativa del potere, egualmente intermittente, del capo dello stato, al fine di porre rimedio al conflitto tra governo e parlamento. Redslob aggiunge che il regime parlamentare è come una bilancia che il capo dello stato tiene nelle sue mani: i due piatti sono il parlamento e il governo e il loro equilibrio è mantenuto attraverso i poteri (regi o presidenziali) di nomina e revoca del gabinetto e di scioglimento delle camere[4].
Per descrivere in che modo si realizza esattamente il meccanismo che assicura l’equilibrio del governo parlamentare, il giurista alsaziano si sofferma sulla connessione tra il potere di revoca del gabinetto e il potere di dissoluzione delle camere, formulando un’ipotesi su cui vale la pena riflettere: «se il capo dello stato – scrive Redslob – vuole sbarazzarsi di un gabinetto che ha il sostegno di una maggioranza parlamentare, è obbligato a decretare nuove elezioni al fine di distruggere questa maggioranza. E secondo il successo del tentativo, o si sarà liberato del vecchio gabinetto o sarà obbligato a tenerselo»[5]. È la «dissolution antigouvernementale». Pertanto il nesso tra revoca del gabinetto e scioglimento del parlamento costituirebbe in ciò: se il gabinetto che il capo dello stato intende revocare non ha (più) una maggioranza parlamentare, nulla quaestio; se però ne ha il sostegno, allora la revoca non potrà realizzarsi in altro modo se non sciogliendo il parlamento per indire nuove elezioni.
Senonché ciò è condivisibile solo presupponendo che il potere di scioglimento appartenga esclusivamente al capo dello stato e che il relativo decreto non debba essere controfirmato dal gabinetto: se infatti fosse prevista la controfirma e venisse negata, in che modo il capo dello stato potrebbe disporre la dissoluzione del parlamento? In altre parole, Redslob sembra invertire i termini della questione: in realtà nel regime parlamentare classico non era l’esercizio del potere di scioglimento a rendere possibile la revoca del gabinetto, ma esattamente il contrario, ossia era la revoca del gabinetto contrario allo scioglimento e la sua sostituzione con uno nuovo che fosse disposto a controfirmare il decreto di dissoluzione, a rendere possibile le elezioni anticipate!
Ma cosa succede una volta che, con le costituzioni razionalizzate, scompare il potere di revoca? Viene meno un pezzo essenziale del meccanismo complessivo che dovrebbe assicurare il carattere equilibrato e bilanciato del regime parlamentare; e viene meno perciò la possibilità di definire come parlamentari quei sistemi dove il capo dello stato non può revocare il gabinetto. Ma cosa sarebbero, allora? Redslob non lo spiega.
Peraltro è la stessa immagine della bilancia ad essere fuorviante. Non è chiaro, infatti, da cosa tragga legittimazione il piatto corrispondente all’esecutivo. Se tra questo e il legislativo c’è un rapporto equilibrato e paritario grazie al capo dello stato (e agli appelli al popolo che egli può disporre), si deve presumere che l’esecutivo e il legislativo abbiano titoli di legittimazione distinti ma forti in eguale misura: se nel caso del parlamento questo titolo è l’investitura popolare, non si capisce quale sia nel caso del governo. Non può essere sempre la volontà del popolo, perché questa esprime direttamente soltanto l’assemblea elettiva. Sarà allora la volontà del capo dello stato. Ma in tal caso dobbiamo concluderne che quest’ultimo tiene l’equilibrio tra sé (o una parte di sé) e il parlamento: il che non avrebbe però molto senso.
In definitiva, la rappresentazione del sistema parlamentare offerta da Redslob non descrive esattamente né la logica dualista del parlamentarismo ottocentesco (perché fraintende il rapporto tra revoca del gabinetto e scioglimento del parlamento), né tantomeno la logica dei sistemi parlamentari che scaturiscono dal processo di razionalizzazione: non per caso esclude che siano riconducibili al modello parlamentare quegli assetti nei quali il capo dello stato non è un re, ma un presidente. La repubblica parlamentare sarebbe perciò un ossimoro[6].
2. – …e
nel pensiero di Georges Burdeau
Anche Georges Burdeau nel 1932 descrive il regime parlamentare come un assetto equilibrato che bilancia più centri di potere posti in condizione d’uguaglianza:
«l’essenza stessa del parlamentarismo (è) il dualismo e la collaborazione dei poteri»[7].
È una definizione sintetica che aspira a racchiuderne sinteticamente lo spirito. Dualismo e collaborazione sono due termini-chiave che indicano caratteri distinti ma correlati dei sistemi parlamentari e che costituiscono la risultante del combinarsi e dell’operare congiunto dei seguenti elementi: «l’irresponsabilità del capo dello Stato, la responsabilità dei ministri, il diritto di scioglimento e quello di controllo del Parlamento»[8].
Per chiarire come gli istituti elencati si amalgamino nel meccanismo parlamentare occorre riflettere – a giudizio di Burdeau – sulla grande questione teorica della separazione dei poteri. Anzitutto si precisa che sarebbe sconsigliabile una sua ricezione troppo rigida. Nelle esperienze parlamentari europee, infatti, la separazione dei poteri «si è rivelata come una massima di arte politica la cui applicazione deve essere moderata che non come una regola rigida di organizzazione statuale»[9].Ma in cosa consisterebbe esattamente la «meno rigida concezione europea della separazione dei poteri»?
La risposta di Burdeau non è, per la verità, del tutto intelligibile. Esordisce dicendo che «consiste non nel rinchiudere ciascuna delle due attività nella sfera puramente legislativa o in quella puramente esecutiva, ma nel riconoscerle un’indipendenza relativa nell’adempimento della funzione per la quale è istituita»[10]. Ciò dovrebbe significare che è ben possibile che organi legislativi partecipino della funzione esecutiva e che organi esecutivi partecipino di quella legislativa. È una lettura che parrebbe confermata qualche riga dopo, quando si osserva che «ad una stessa funzione devono partecipare autorità diverse». Sotto questo profilo, sembra che Burdeau voglia suggerire che nei sistemi parlamentari autentici la connessione funzionale convive con la separazione organica (né più né meno di quanto accade nell’esperienza statunitense).
In realtà, ad una lettura più attenta, le cose non si rivelano proprio in questi termini. Burdeau, infatti, dice che l’«indipendenza relativa» degli organi «si oppone alle interferenze» e che «non costituisce un ostacolo alla collaborazione dei poteri»[11]: ora, è evidente che se l’indipendenza esclude le interferenze, si fa riferimento al piano funzionale; e che se questa separazione funzionale non esclude la collaborazione dei poteri, è perché tra i poteri c’è una condizione di equilibrio che è resa possibile proprio dall’esistenza di connessioni organiche. In altre parole, pur avendo funzioni distinte e separate, ciò nondimeno gli organi legislativi ed esecutivi sono indotti a collaborare da alcuni istituti e meccanismi che li pongono in contatto reciproco: precisamente dal «principio della responsabilità politica del governo» (di fronte al parlamento) e dal «diritto di scioglimento dell’Assemblea che spetta all’esecutivo»[12].
In definitiva, il legislativo e l’esecutivo sono funzioni distinte. Ma giacché il primo può sfiduciare il secondo e il secondo può sciogliere il primo, ciascuno sarà indotto ad esercitare le proprie funzioni ricercando la collaborazione dell’altro.
Fin qui nulla di veramente nuovo. Burdeau descriverebbe lo stesso fenomeno già raccontato decenni prima da Walter Bagehot[13]: il potere parlamentare di sfiduciare il governo e il potere governativo di sciogliere il parlamento sono due risorse eguali e contrarie, che si neutralizzano reciprocamente, ponendo i loro detentori in una situazione di perfetta eguaglianza ed equilibrio. Dualismo e collaborazione, appunto.
Diversamente da Bagehot, Burdeau però, nel descrivere le condizioni indispensabili di un siffatto assetto dualistico equilibrato, evoca il ruolo determinante di un terzo organo: il capo dello Stato. Il dualismo equilibrato tra potere legislativo e potere esecutivo si regge quindi sul gioco d’interazioni che s’instaura non tra due, ma fra tre organi: il parlamento (monocamerale o bicamerale), il gabinetto e il capo dello Stato. Di qui la celebre formula: «due poteri, tre organi», che a giudizio di Burdeau racchiude «tutta la complessità del sistema parlamentare»[14].
In particolare, mentre al parlamento spetta il potere legislativo, «il potere esecutivo è affidato ad un sovrano ereditario, o ad un Presidente della Repubblica, al quale si affiancano i ministri da esso nominati ma responsabili di fronte al Parlamento»[15]. Per usare una formula estesa, «si può definire il regime parlamentare come una forma di governo rappresentativo basato sulla collaborazione dei poteri, tuttavia distinti, nella quale, da un lato il Gabinetto dei ministri detiene la direzione e l’iniziativa del governo sotto il controllo delle Camere che possono obbligarlo a dimettersi per mezzo del voto di sfiducia e nella quale, dall’altro, il capo dello Stato può, dietro richiesta del Gabinetto, opporsi alla volontà del Parlamento proclamandone lo scioglimento, pur essendo tenuto, come contro-partita della sua irresponsabilità politica, a sottomettersi alle decisioni prese dal corpo elettorale»[16].
È evidente che se si accede a questa ricostruzione, ogni ipotesi di razionalizzazione che preveda, ad esempio, la limitazione del diritto di scioglimento del parlamento o l’elezione parlamentare del gabinetto ovvero qualsiasi altra misura diretta a ridimensionare, se non ad eliminare, il ruolo del capo dello stato, non potrà che compromettere l’equilibrio dualistico e collaborativo che caratterizza – a giudizio di Burdeau – l’autentico parlamentarismo[17]: il governo parlamentare razionalizzato, quale risultava dalle nuove costituzioni europee posteriori al 1918, avrebbe pertanto poco a che spartire con l’essenza più profonda dei sistemi parlamentari.
Giunti sin qui, bisogna ovviamente chiedersi se vi sia un’essenza del parlamentarismo e, prima ancora, chiedersi se quell’essenza che Burdeau ritiene di avere individuato abbia un grado soddisfacente di coerenza interna.
3. – Segue:
l’abbaglio del dualismo collaborativo
Il dualismo equilibrato e collaborativo che Burdeau crede di scorgere nell’autentico parlamentarismo, è invero un abbaglio.
Anzitutto non è chiaro a cosa ci si riferisca precisamente quando si ragiona di dualismo e quando si postula che un vero regime parlamentare è fondato «sull’uguaglianza e la collaborazione dei poteri»[18].
La confusione è generata proprio dalla formula «due poteri, tre organi». Riferire il dualismo, l’equilibrio, l’eguaglianza e la collaborazione ai due poteri (legislativo ed esecutivo) anziché ai tre organi, cioè alle qualità astratte, alle funzioni in sé considerate anziché agli attori costituzionali concreti, non pare un’ipotesi praticabile: che senso avrebbe, infatti, affermare che tra due funzioni distinte c’è eguaglianza, equilibrio e collaborazione? Se fare le leggi e applicarle/eseguirle sono due attività eterogenee, qualitativamente differenziate, dire che il loro rapporto è o deve essere equilibrato, paritario e collaborativo, può significare soltanto che ciascuna deve rispettare l’ambito in cui opera l’altra, senza interferenze reciproche. Ciò però sarebbe – per usare la terminologia dello stesso Burdeau – «soltanto una separazione delle funzioni, ma non una separazione dei poteri» e ben potrebbe convivere con un impianto monistico in cui ci fosse un potere unitario di direzione politica[19]. Si tratta dunque di un’interpretazione da scartare.
L’interpretazione alternativa è, allora, che il dualismo, l’equilibrio, l’eguaglianza e la collaborazione caratterizzino il rapporto tra i tre organi e non quello tra i due poteri. Ma anche accogliendo questa lettura, i conti non tornano.
In primo luogo non è chiaro quali sono i termini soggettivi del rapporto dualistico: il capo dello stato e il parlamento? Oppure il gabinetto e il parlamento? Burdeau sembra oscillare tra le due ipotesi. Dapprima afferma che il gabinetto è «un organo intermedio fra il capo dello Stato ed il Parlamento» e che «dipendendo nello stesso tempo dal potere esecutivo e da quello legislativo, è il Gabinetto che permette loro di influire l’uno sull’altro»[20]. E aggiunge inoltre che «il parlamentarismo è un regime dualistico nel quale il potere statuale è destinato a collaborare» e che, pertanto, «tale collaborazione si attua pel tramite del ministero», il quale «da un lato «espone al capo dello Stato le opinioni del Parlamento e dall’altro rappresenta, di fronte all’Assemblea, il potere esecutivo ed agisce come tale». Se ne dovrebbe dunque inferire che il gabinetto è l’organo di raccordo che stempera l’antagonismo dualistico, consentendo il funzionamento armonico delle attività statali fondamentali. Sarebbe, però, una conclusione affrettata. Subito dopo, infatti, Burdeau rimescola abilmente le (tre) carte e con destrezza indica nel capo dello stato il punto d’equilibrio dello schema dualistico, ossia «l’organo di coordinamento che intervenga, presentandosene il caso, fra ministero ed Assemblea per attenuare un antagonismo nel quale l’interesse dello Stato potrebbe correre il rischio di essere trascurato»[21].
Analoga confusione si registra riferendo ai tre organi (anziché ai due poteri) l’idea che abbiano «un uguale prestigio ed una uguale influenza»[22]. Non si può dire, infatti, che tra parlamento e gabinetto vi sia perfetta uguaglianza nel prestigio, perché l’investitura democratica dell’assemblea elettiva è più forte di quella, mediata, del gabinetto. E neppure c’è nell’influenza, vista la possibilità per il parlamento di sfiduciare il gabinetto. Può obiettarsi che quest’ultimo può sciogliere l’assemblea, ma deve però precisarsi che può farlo solo se vi è l’accordo del capo dello stato: il che significa che semmai ci può essere eguaglianza tra il parlamento, da una parte, e l’unione di capo dello stato e gabinetto dall’altra.
Per certi versi lo stesso ragionamento vale pure riguardo al rapporto tra parlamento e capo dello stato. Questo non può esibire il medesimo prestigio dell’altro, se non nella monarchia in cui non sia ancora profondamente radicato il principio democratico[23]. E neppure può, da sé, esercitare la medesima influenza del parlamento, visto che non può inibirne la funzione legislativa, né può scioglierlo senza l’accordo del gabinetto. In definitiva, se d’eguaglianza può parlarsi, questa non è tra i tre organi che compongono il regime parlamentare, ma semmai potrebbe instaurarsi tra il potere legislativo del parlamento e il potere esecutivo in quanto esercitato di comune accordo tra capo dello stato e gabinetto: ma è nondimeno evidente che laddove non vi fosse accordo tra gabinetto e capo dello stato, tale eguaglianza tra legislativo ed esecutivo verrebbe meno[24].
Ovviamente il tipo d’accordo tra gabinetto e capo dello stato che possa efficacemente controbilanciare il potere parlamentare, è quello che si registra in occasione dell’emanazione del decreto di scioglimento delle camere: il gabinetto, infatti, trae «questa potestà, ch’esso non trova in sé, dall’appoggio del capo dello Stato. Grazie al suo potere di scioglimento questi può permettere al ministero di resistere efficacemente all’Assemblea»[25].
Come si vede, alla fine Burdeau appende la natura dualistica del regime parlamentare alla possibilità del gabinetto di richiedere al capo dello stato la dissoluzione del parlamento: possibilità che, beninteso, il capo dello stato può accordare come negare[26]. Questo significa che c’è dualismo solo quando il capo dello stato e il gabinetto fanno fronte comune contro il parlamento, sciogliendolo anticipatamente. Occorre però chiedersi se ciò sia vero dualismo. Invero questo ricorre quando possono stabilmente convivere (almeno) due indirizzi politici divaricati, come nel sistema presidenziale statunitense. Invece nel caso considerato abbiamo solamente una sorta di dualismo intermittente, che si manifesta solo in occasione delle crisi di gabinetto e solo se queste vengono risolte con lo scioglimento disposto dal capo dello stato su richiesta del governo.
Evidentemente è un po’ poco perché si possa parlare di vero dualismo. In realtà, una volta che dal disegno costituzionale della forma di governo scompare il potere regio (o presidenziale) di revoca unilaterale del gabinetto, con ciò liberando i ministri dal vincolo fiduciario che un tempo li legava al capo dello stato oltre che al parlamento, fatalmente viene meno la condizione necessaria perché un assetto di tipo parlamentare possa caratterizzarsi in senso dualistico[27].
4. – L’equilibrio
del regime parlamentare tra rappresentanza e identità nel pensiero di
Carl Schmitt
È difficile cancellare le tracce del tempo passato. Le raffigurazioni dualistiche del regime parlamentare che abbiamo appena esaminato, si collocano nella prima metà del XX secolo e ripetono in modo inerziale schemi di pensiero legati alla lunga esperienza del parlamentarismo dualista ottocentesco.
A riprova della vischiosità della tradizione storica, anche Carl Schmitt, nel 1928, anno di pubblicazione della Verfassungslehre, non può fare a meno di riproporre, almeno sul piano formale, le vecchie teorie dell’«equilibrio parlamentare». Ma come vedremo, non aderisce sostanzialmente all’idea che il sistema parlamentare realizzi un assetto di potere autenticamente dualistico.
Anzitutto il discorso schmittiano prende le distanze dalla concezione «puramente democratica» del parlamentarismo, che condurrebbero ad una sorta di «assolutismo parlamentare»[28]. Questa concezione postula la «dipendenza del governo dalla volontà della rappresentanza popolare», trasformando l’esecutivo in «un mero comitato della rappresentanza popolare, ossia del parlamento» e, a sua volta, il parlamento in «un mero comitato del popolo»[29]. A seguire Schmitt, si tratterebbe di uno schema teorico che si regge su «un duplice rapporto di sovra- e subordinazione; il popolo (gli elettori con diritto di voto) sta al di sopra della rappresentanza popolare (il parlamento), la rappresentanza popolare al di sopra del governo». Da qui, appunto, «un sistema di comitati: la rappresentanza popolare (il parlamento) è un comitato del popolo (degli elettori con diritto di voto); il governo parlamentare è un comitato della rappresentanza popolare (del parlamento)». Col risultato che «l’organizzazione statale appare come un sistema di comitati con tre gradi: popolo, rappresentanza popolare, governo»[30].
A questa concezione, «puramente democratica», del parlamentarismo Schmitt contrappone «l’essenza del “vero” parlamentarismo»; e ricollegandosi espressamente alla riflessione di Robert Redslob, afferma che questa «essenza (…) consiste proprio nel fatto che l’Esecutivo non è lo strumento subordinato della volontà parlamentare, ma esiste un equilibrio fra due poteri»[31]. In particolare, tale equilibrio parlamentare
«si basa su di una utilizzazione e commistione di elementi politici diversi e persino opposti. Esso adopera costruzioni monarchiche per rafforzare l’Esecutivo, cioè il governo, e per controbilanciare il parlamento; impiega l’idea aristocratica di un corpo rappresentativo, in taluni Paesi anche quella del sistema bicamerale; utilizza concezioni democratiche del potere decisionale del popolo non rappresentato, ma direttamente votante, soprattutto per demandargli in un conflitto fra parlamento e governo la decisione del conflitto, ragione per cui di fronte al parlamento e al governo appare come il terzo in più alto grado e come il reggitore della bilancia»[32]
Il parlamentarismo dunque non è il prodotto esclusivo del pensiero democratico, poiché in realtà assomma elementi riconducibili a principi diversi di forma politica: quello monarchico, che s’incarna nel ruolo riconosciuto all’esecutivo; quello aristocratico, che s’incarna nel ruolo riconosciuto alle camere rappresentative; e infine quello democratico, che emerge quando in seguito al conflitto tra esecutivo e camera elettiva, quest’ultima viene sciolta per consentire l’«appello al popolo» quale istanza terza cui si demanda la decisione del conflitto.
Per intendere compiutamente il senso di questa ricostruzione del parlamentarismo dobbiamo tenere presente la tesi schmittiana secondo cui in ogni forma o tipo di stato ritroviamo sia gli elementi strutturali del «principio di rappresentanza», sia gli elementi strutturali del «principio di identità»[33]. In particolare, nel caso dello Stato parlamentare, mentre l’elemento monarchico e quello aristocratico declinano il «principio di rappresentanza», l’elemento democratico corrisponde invece – e non potrebbe essere altrimenti – al «principio dell’identità». Ma qual è il significato di questi due diversi «principi di forma politica», ossia l’identità e la rappresentanza? E perché non esiste forma di stato in cui non li rinveniamo entrambi, pur variamente combinati?
Come lo stesso Schmitt ricorda, la parola “stato” deriva dal latino status e designa «un determinato status di un popolo, e precisamente lo status dell’unità politica»[34]. Con “stato” s’intende dunque la condizione in cui si trova un popolo politicamente unito[35]. Di ogni cosa si può dire che abbia uno status e che esso può mutare secondo le circostanze: col variare della temperatura le particelle d’idrogeno ed ossigeno definite dalla formula chimica H²O possono variare di status e passare dallo stato liquido a quello gassoso, a quello solido. Analogamente una stessa persona può passare dallo status di celibe a quello coniugale. Insomma lo status non è altro che la condizione in cui una determinata cosa (o persona o ente) si trova in un momento dato e con circostanze date. Ebbene, questa parola “stato” (o “Stato”) designa pure la condizione in cui si trova un popolo quando è politicamente unito, cioè – per dirlo con le categorie schmittiane – quando è capace di agire politicamente e distinguere l’amico dal nemico.
Resta allora da capire in che modo il popolo può diventare “stato”, ossia raggiungere lo status, la condizione dell’unità politica. Qui entra in gioco la distinzione tra identità e rappresentanza quali diversi «principi della forma politica». L’unità politica di un popolo si può infatti conseguire in due modi differenti: o essa si manifesta di per sé, quasi in modo naturale e spontaneo, cioè come «identità del popolo presente con se stesso», oppure può raggiungersi attraverso la rappresentanza. Nel primo caso il popolo
«può già nella sua immediata datità – in virtù di una forte e consapevole omogeneità, in seguito a stabili confini naturali o per qualsiasi altra ragione – esser capace di agire politicamente (…) esso è, come entità realmente presente nella sua immediata identità con se stesso, una unità politica»[36]
Quando il popolo in quanto tale, ossia come entità realmente presente, è già di per sé capace di volere e agire come un’unità e senza mediazioni rappresentative, allora possiamo dire che non c’è una distinzione tra dominanti e dominati e che, al contrario, vige «l’identità dei dominanti e dei dominati, dei governanti e dei governati, di quelli che comandano e di quelli che ubbidiscono»[37]: insomma vige ciò che, secondo Schmitt, prende il nome di «democrazia», la quale pertanto è «una forma di Stato che corrisponde al principio di identità (cioè del popolo concretamente esistente con se stesso in quanto unità politica)»[38].
Individuando nel «principio dell’identità» la forma specifica d’unità politica di uno Stato democratico, Carl Schmitt riporta la parola «democrazia» al suo significato originario: essa è la volontà unitaria che in modo spontaneo e immediato emana da un popolo concretamente esistente.
«L’attuazione del principio di identità significa la tendenza al minimo di governo e di direzione personale. Quanto più si attua questo principio tanto più si compie “da se stessi” il disbrigo degli affari politici, grazie ad un massimo di omogeneità naturalmente dato o storicamente formatosi. È questa la condizione ideale di una democrazia, come la presuppone Rousseau nel Contrat social»[39]
Se è inteso in quest’accezione roussouiana, il principio democratico dell’identità non ha nulla a che vedere col principio (monarchico e/o aristocratico) della rappresentanza; e coerentemente, la c.d. «democrazia rappresentativa» dev’essere trattata alla stregua di un ossimoro[40].
Sennonché ciò «è da considerare solo come una costruzione ideale astratta, non come una realtà politica e storica». È chiaro infatti che dove c’è l’omogeneità sostanziale del popolo e «dove tutto concorda, la decisione deve prodursi da sé senza discussione e senza contrasti di interessi essenziali, poiché tutti vogliono la stessa cosa»[41]: tuttavia tale condizione è solo una finzione e «una totale, assoluta identità del popolo di volta in volta presente con se stesso in quanto unità politica non esiste in nessun luogo e in nessun istante»[42].
Ne viene dunque che in ogni forma di stato immaginabile e possibile, per raggiungere lo status, la condizione dell’unità politica occorre la rappresentanza, il cui principio «parte dall’idea che l’unità politica del popolo in quanto tale non può mai essere presente nella reale identità e perciò deve sempre esser rappresentata fisicamente da uomini»[43]. Sicché «non c’è nessuno Stato senza rappresentanza»[44].
5. – Segue: i
«sottosistemi» del regime parlamentare e l’unicità del
rappresentante sovrano
Nel linguaggio della scienza politica contemporanea espressioni come “rappresentanza politica” o “governo rappresentativo” evocano la presenza necessaria e fondamentale di un’assemblea elettiva e una grande diffusione dei diritti politici di elettorato attivo e passivo. Sono ormai divenute sinonimo di “governo democratico”.
Tuttavia, quando Schmitt ragiona di «principio della rappresentanza come forma politica», non si riferisce specificamente alla “rappresentanza elettiva”. Anzi, a suo giudizio, nella misura in cui, sotto la pressione d’istanze democratiche, la rappresentanza parlamentare eletta a suffragio universale viene indicata come la sola forma legittima di rappresentanza politica, si verifica fatalmente uno snaturamento del principio rappresentativo, perché non è più l’unità politica in quanto tale ad essere rappresentata, ma gli interessi sociali organizzati, con l’effetto di trasformare l’assemblea elettiva in un «comitato di rappresentanti di interessi»[45].
Cosa intende allora Schmitt per «principio della rappresentanza»?
Sulla scia della tradizione precisa che
«rappresentare significa rendere visibile e illustrare un essere invisibile per mezzo di un essere che è presente pubblicamente. La dialettica del concetto consiste nel fatto che l’invisibile è presupposto come assente ed è al tempo stesso reso presente»[46]
Ma cos’è precisamente questo «essere invisibile» che è reso presente pubblicamente tramite la rappresentanza? Non è il popolo nella sua concreta esistenzialità e, quindi, nella somma degli interessi reali, volontà, aspirazioni, passioni, ecc., che formano la sua composizione effettiva in un momento storico dato. Tutto ciò infatti non è certo quell’«essere invisibile» che è reso presente nella rappresentanza: nella concreta materialità delle sue varie componenti il popolo reale è invero qualcosa di molto visibile, quasi tangibile. Ciò che esiste realmente, e con una fisionomia ben riconoscibile, non ha certo bisogno di essere rappresentato, ossia tradotto in quella forma particolare d’esistenza pubblica di cui consiste, appunto, la rappresentanza. Al contrario
«nella rappresentanza si manifesta concretamente una più alta specie di essere. L’idea della rappresentanza si basa sul fatto che un popolo che esista come unità politica, rispetto all’esistenza naturale di un qualsiasi gruppo di uomini che vivano insieme ha una specie di essere più alta e sviluppata, più intensa»[47]
Ciò che viene rappresentato, allora, non è «l’esistenza naturale di un qualsiasi gruppo di uomini che vivano insieme», cioè non è «il popolo nella sua esistenza naturale», nella concreta esistenzialità che lo connota in un momento dato. Rappresentare questo equivarrebbe semplicemente a rispecchiarlo. Ma ciò che viene rispecchiato non è, per ciò stesso, trasformato in un’unità politica di volontà e d’azione, cioè in «una specie di essere più alta e sviluppata», mentre la funzione della rappresentanza consiste propriamente in questo: ossia, nel conferire ad una totalità indifferenziata di individui concreti, ad una moltitudine disunita e dispersa, lo status di soggetto capace di agire politicamente in modo unitario[48].
Da ciò discendono due conseguenze, che costituiscono uno snodo cruciale per intendere la concezione schmittiana del sistema parlamentare.
In primo luogo si afferma una perfetta coincidenza tra funzione rappresentativa e funzione di governo o direzione politica: «non qualsivoglia organo è rappresentante», perchè «solo chi governa partecipa alla rappresentanza»[49]. Ma questo significa pure che chi esercita, in un momento storico dato, il potere di direzione politica, è per ciò stesso il rappresentante dell’unità politica[50].
In secondo luogo si postula che nel medesimo Stato non possano esserci più rappresentanti dell’unità politica in concorrenza tra loro; e quindi più organi, monocratici o collegiali, che siano investiti della funzione di direzione politica. Diversamente, come potrebbe trasformarsi una moltitudine in un’unità?[51]
Ma allora, che n’è del dualismo e dell’equilibrio del sistema parlamentare? Se è vero che questo declina il principio della rappresentanza tanto nella forma monarchica del comando di un uomo solo, quanto nella forma aristocratica del comando dei pochi (che siedono nelle Camere legislative), dobbiamo dunque concluderne che – contro le stesse premesse teoriche poste da Schmitt – sono ben possibili più rappresentanti dell’unità politica (il re/presidente capo dell’esecutivo e il parlamento) e quindi più organi investiti del potere ultimo di governo?
Nient’affatto. Schmitt infatti sostiene che questa «utilizzazione e commistione di elementi politici diversi e persino opposti» di cui consisterebbe il sistema parlamentare, realizza un «labile equilibrio di forme politiche»[52]: in nessuno Stato, ivi compreso quello parlamentare, sarebbe possibile la stabile convivenza di due o più centri distinti e concorrenti di direzione politica e di rappresentanza dell’unità politica; e se dualismo c’è, questo non può che avere carattere transitorio, fatalmente destinato perciò a sfociare nella preminenza di uno sull’altro (o sugli altri).
Ricapitolando: da una parte il parlamentarismo è una commistione di elementi monarchici, aristocratici e democratici; dall’altra, però, non si possono realizzare stabili condizioni di “governo misto”, con un’equilibrata distribuzione della funzione di indirizzo politico. Ciò significa che in talune fasi, e in relazione a taluni caratteri del sistema politico, potrà aversi la preminenza dell’elemento monarchico, in altre fasi, e con condizioni politiche diverse, potrà aversi invece la preminenza dell’elemento aristocratico, e così via.
«In modo corrispondente all’utilizzazione dei diversi elementi di forma politica con il sistema parlamentare possono essere realizzate diverse specie di direzione e di guida politica (di “ruling power”, di determinazione della “politique générale” o delle “linee fondamentali della politica”)»[53].
In particolare, all’interno di un sistema parlamentare possono realizzarsi almeno «quattro diversi sottosistemi»[54], corrispondenti a quattro diverse determinazioni e individuazioni di quale sia l’organo supremo di direzione (e di rappresentanza dell’unità) politica. Di conseguenza: 1) se prevale l’elemento monarchico, cioè l’idea della rappresentanza dell’unità politica «per mezzo di un singolo uomo», avremo un sistema “presidenzial-parlamentare”, dove «il capo dello Stato, il capo dell’esecutivo, partecipa autonomamente alla guida politica»; 2) se prevale l’idea aristocratica, avremo un «sistema parlamentare in senso stretto, in cui la maggioranza del corpo legislativo ha la direzione politica»; 3) se invece è «il capo di questa maggioranza parlamentare» a detenere la guida politica, «si ha allora un sistema a premier»; se, infine, succede «che non il singolo capo di partito e presidente del consiglio dei ministri abbia la guida e la direzione politica, ma il collegio dei ministri, che è di solito un ministero di coalizione composto da diversi partiti», allora avremo un «sistema di gabinetto»[55].
Diversamente da Redslob e Burdeau, quando Schmitt descrive il “vero” sistema parlamentare come un sistema di commistione tra elementi politici diversi, non intende ravvisare nel dualismo l’essenza del sistema parlamentare. Il potere di direzione (e di rappresentanza dell’unità) politica è sempre unitario ed esclusivo.
Semmai il riferimento alla «commistione di elementi politici diversi» spiega perchè il parlamentarismo consente ben quattro diverse dislocazioni alternative del potere di direzione politica. Sicché una costituzione che prevedesse un sistema parlamentare, ospiterà sempre, e nella sua interezza, questo ampio spettro di possibilità, senza poter mai predeterminare con precisione infallibile dove in concreto si localizzerà il potere direttivo dominante:
«riguardo al governo parlamentare non è sufficiente né il testo scritto della legge costituzionale né il chiaro contenuto di una prassi costante per dare un significato univoco al concetto di “governo parlamentare”. Dal fatto che una disciplina legislativo-costituzionale voglia introdurre un “governo parlamentare”, non si può ancora dedurre se il presidente dello Stato o il presidente del consiglio dei ministri o la maggioranza della camera determini le direttive politiche»[56]
Per farla breve, da un lato la disciplina costituzionale di un governo parlamentare non potrà mai impedire che si formi un potere unitario ed esclusivo di direzione politica, dall’altro non potrà mai predeterminare in corrispondenza di quale organo si localizzi[57].
Tuttavia questo secondo profilo – contrariamente all’avviso di Schmitt – non dipende dalla «commistione di elementi politici diversi» e dalla conseguente possibilità che si affermi l’elemento monarchico in luogo di quello aristocratico o viceversa. Non è l’oscillazione tra concezioni alternative circa la titolarità della funzione di rappresentanza dell’unità politica: ossia, se a governare debba essere uno solo o i pochi ovvero i molti. In realtà le differenze tra il governo del premier, quello del gabinetto e quello d’assemblea sono legate perlopiù ai caratteri strutturali del sistema democratico dei partiti e quindi al tipo di rapporti che s’instaurano tra questi in seno all’assemblea elettiva. La ragione per cui il governo parlamentare può produrre diversi «sottosistemi», dipende più dal numero e dalla natura dei partiti che ottengono seggi parlamentari che non da una lotta che l’uno, i pochi e i molti intraprendono per conquistare la funzione di rappresentanza dell’unità politica.
Alfine è proprio la concezione compiutamente democratica del parlamentarismo, cui Schmitt sembra non dare particolare credito neppure sul piano euristico, a poter spiegare il fenomeno dei c.d. «sottosistemi». Nel regime parlamentare, infatti, le diverse dislocazioni e intensità del potere effettivo di direzione politica dipendono sempre dalla composizione della maggioranza parlamentare (se bipartitica ovvero multipartitica) e dal grado di coesione della stessa.
Ad esempio, la preminenza politica del premier anziché del gabinetto o dell’assemblea non è la vittoria dell’elemento propriamente monarchico, cioè dell’idea del comando di uno solo anziché dei pochi ovvero dei molti. E non testimonia perciò la sconfitta dell’elemento aristocratico o democratico, con la conseguente marginalizzazione del parlamento. Si tratta invece di un effetto legato alla struttura bipartitica della composizione assembleare ed è quindi un fenomeno perfettamente spiegabile alla luce della «concezione puramente democratica dell’assolutismo parlamentare». Lo stesso vale per gli altri «sottosistemi»: è sempre la situazione parlamentare dei partiti il fattore che individua la fisionomia concreta della funzione di governo.
6. – Il monismo necessario nel pensiero
di Costantino Mortati
Negli anni ’30 del secolo scorso la linea d’indagine di Carl Schmitt viene parzialmente ripresa da Costantino Mortati.
È comune ad entrambi l’idea che la disciplina costituzionale – la «legge costituzionale», per essere precisi – non possa predeterminare in modo infallibile la dislocazione concreta della direzione politica:
«una precisa determinazione della posizione costituzionale di un organo non è sufficiente a garantire che la funzione di quest’organo si svolga nel senso previsto o che raggiunga i fini, a cui mirava la determinazione legislativa stessa»[58]
Ma soprattutto è comune ad entrambi la visione rigidamente monistica del governo parlamentare. Per Schmitt guidare politicamente un popolo significa rappresentarne l’unità politica: la sovranità non si può dividere e pertanto un solo organo statale alla volta può detenere il potere ultimo di comando[59]. Per Mortati la sostanza rimane la medesima. Alla base d’ogni organizzazione statale vi è un’«attività di governo», da cui dipende l’unità dell’ordinamento. Si tratta di un’esigenza necessaria che deve essere soddisfatta in ogni forma statuale, quale ne sia il tipo.
In particolare, il bisogno di un’attività o funzione di governo sorgerebbe dalla realtà della separazione dei poteri:
«il problema del governo e la specifica rilevanza giuridica che essa viene ad assumere nascono (…) dalla struttura che allo Stato stesso è stato impresso da quel complesso di principi propri della teoria della separazione dei poteri»[60]
L’attività di governo non si riduce a nessuna delle (tre) funzioni tradizionali dello stato, né dal punto di vista materiale od oggettivo (guardando, cioè, al contenuto dell’attività svolta), né dal punto di vista subiettivo (guardando, cioè, all’organo che svolge l’attività detta). Sicché per Mortati la separazione dei poteri non offre alcuna soluzione al problema di capire quale potere od organo sia titolare della funzione di governo: semmai crea tale problema, ponendoci di fronte alla questione dell’esatta individuazione dell’organo o potere la cui attività assicura l’unità complessiva dell’ordinamento a dispetto delle divisioni e articolazioni funzionali.
Sintetizzando tutto ciò in modo icastico, può dirsi che il
«Governo è il principio d’unità, posto accanto al principio di divisione e pertanto non può essere individuato ove si rimanga nell’ambito di quest’ultimo»[61]
Il discorso mortatiano è chiaro. Gli stati moderni sono ordinamenti complessi che ripartiscono le funzioni pubbliche tra una pluralità di organi diversi. Al «principio di divisione» occorre però affiancare quello «d’unità» come momento necessario di coordinazione delle attività statali particolari. La funzione di governo è quindi parte integrante dell’ordinamento giuridico statale. Di più, è presupposto di possibilità dell’ordinamento e condizione della sua pluralità organica:
«riesce impossibile mantenere l’unità della volizione dello Stato senza una tale attività (di governo) che raggruppi intorno ai fini generali le volontà singole: solo a tale condizione ed entro questi limiti è possibile ammettere l’esistenza di una pluralità di organi autonomi»[62]
Il compito della funzione di governo è
«ricostituire ciò che la divisione delle competenze e degli organi necessariamente divide e di ricostituirli intorno a un centro unitario (…) ha come scopo diretto l’unità, e pertanto agisce come principio motore di tutto il complesso dell’attività statale: indica ai vari organi la via e riconosce la conformità dei loro atti al fine»[63]
Resta però da chiarire un punto d’importanza decisiva nella costruzione mortatiana: in che modo l’attività di governo sortisce il suo effetto e le direttive dell’organo supremo condizionano l’attività degli altri organi? Si tratta, cioè, di capire come l’unità della funzione di governo riesce a prevalere sulla divisione funzionale implicata dalla separazione dei poteri.
La risposta di Mortati è chiara e rimarrà la stessa anche nella successiva monografia del ’40 sulla costituzione materiale:
«quando, in caso di dissenso con gli altri organi costituzionali, l’organo supremo è chiamato ad esplicare una potestà di ultima decisione, esso la fa valere non attraverso l’esercizio di una coazione, ma in via indiretta, promuovendo il mutamento delle persone fisiche che compongono l’organo dissenziente dalle direttive, in modo che l’atteggiamento di questo si uniformi»[64]
La preminenza dell’organo supremo e della sua funzione di governo è garantita dal potere di determinare la composizione degli altri organi costituzionali. Se chi stabilisce i fini generali dell’ordinamento statale non dispone di questa risorsa di potere, in che modo potrebbe infatti assicurarsi l’unificazione teleologica dell’intera azione statale?
Mortati però non spiega che cosa assicura all’organo supremo il potere di mutare la composizione degli altri organi. Lo farà ne La costituzione in senso materiale, individuando nel partito politico (dominante) il fattore che raccorda e unifica tutti gli organi statali, da quelli supremi a quelli investiti di funzioni meramente esecutive[65].
In ogni modo, per Mortati il regime parlamentare non può che essere necessariamente monista perché qualsiasi assetto statale lo è. Ma cosa succede qualora questa premessa teorica generale dovesse rivelarsi infondata?
7. – L’alternativa
tra monismo e dualismo come criterio di classificazione delle forme di governo
È evidente che la teoria generale della funzione di governo, proposta da Mortati, non è in grado di fornire una chiave esplicativa che possa valere per ogni ordinamento statale possibile.
In particolare, il peculiare rapporto tra «principio d’unità» e «principio di divisione», tra funzione di governo e separazione dei poteri, che L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano teorizza con riferimento ad ogni formazione statale, non è d’alcuna utilità se riferito al costituzionalismo americano, poiché descrive una logica esattamente antitetica rispetto a quella che spesso informa il sistema statunitense. Come già si è ampiamente argomentato[66], la separazione dei poteri (o del potere) cui s’ispira il governo presidenziale nordamericano ha sovente impedito l’emersione sia di un «organo supremo», sia di un’obiettiva «funzione di governo» dal carattere unificante e quindi preminente rispetto ad ogni altra funzione statale[67].
Ciò detto, se il monismo non è il destino necessario d’ogni forma di governo, con quali argomenti si può sostenere il carattere necessariamente monista del governo parlamentare? Non certo desumendo tale natura dal dettato costituzionale: se le disposizioni costituzionali non possono predeterminare con sicurezza chi, in concreto, deterrà il potere unitario di direzione politica, parimenti neanche potranno predeterminarne con certezza l’unitarietà. A parti rovesciate lo stesso dovrebbe valere per il governo presidenziale: le disposizioni costituzionali non possono predeterminarne in modo sicuro il dualismo. Così come il monismo non è il destino necessario d’ogni forma di governo, lo stesso deve dirsi per il dualismo.
Quale bilancio finale può dunque trarsi? Che l’alternativa tra monismo e dualismo non è un valido criterio per cogliere le differenze tra le forme di governo e che perciò deve essere definitivamente abbandonato quale criterio della loro classificazione? Sarebbe una conclusione troppo drastica, perché in realtà bisognerebbe prima intendersi su cosa s’intende precisamente per assetto monista e dualista.
Da come finora ho adoperato questi termini parrebbe che siano moniste quelle forme di governo dove c’è un potere unitario di direzione politica e dualiste quelle dove invece è assente. Tuttavia questa schematizzazione non è corretta, perché – a ben vedere – ha gli stessi difetti che sono imputabili all’uso della nozione di «indirizzo politico» come criterio classificatorio[68]. Quest’ultimo, infatti, non chiarisce se per individuare l’organo supremo di direzione politica si debba guardare al dettato costituzionale o se invece si debba prestare attenzione agli svolgimenti dell’esperienza politica reale. In ogni modo, nel primo caso la lettera delle disposizioni costituzionali non avrebbe comunque rilievo decisivo, come già è sottolineato nei passi di Schmitt e Mortati che ho riportato sopra; nel secondo caso valgono invece le recenti acquisizioni della scienza politica, che preferisce interrogarsi non già su chi sia il potere supremo d’indirizzo politico, bensì su chi sia veto player[69].
Ritornando alla distinzione tra monismo e dualismo, è chiaro che se con questi termini s’intende rispettivamente la presenza e l’assenza di un potere supremo e unitario di direzione politica, avremo per le mani uno strumento d’indagine sommamente impreciso. Vuoi perché non si capisce quali elementi o indici devono considerarsi per ascrivere con certezza e una volta per tutte un dato assetto all’uno ovvero all’altro tipo. Vuoi perché è sovente accaduto che una medesima forma di governo, col subentrare di fasi storiche diverse, abbia offerto una fisionomia ora monista ora dualista[70].
Ciò nondimeno il binomio monismo/dualismo, se riformulato in modo più articolato e raffinato, può essere ancora una risorsa utile per orientarsi tra le differenze e le somiglianze che corrono tra i diversi tipi. In particolare assumerò che una forma di governo è monista quando la sua disciplina giuridico-costituzionale contiene forti incentivi affinché si formi un potere unitario di direzione politica; sarà invece dualista quando prevede forti incentivi affinché sia assai difficile il formarsi di un potere unitario di direzione politico.
Tra questi incentivi è sicuramente da ricondurre la disciplina della separazione dei poteri, la cui importanza – come si vedrà – è fondamentale ma non sempre risolutiva[71].
8. – Segue: i sottotipi
formale e sostanziale
Onde evitare equivoci, quando si parla di “separazione dei poteri” è sempre bene precisare se si fa riferimento al profilo organico o a quello funzionale. Solo tenendo presente le differenze tra i due profili è possibile impiegare tale principio al fine di classificare le forme di governo[72].
Applicando tale modello classificatorio, se ne dovrebbe concludere che ci sono forme di governo in cui è debole la separazione organica e forte la separazione funzionale, come nel governo parlamentare contemporaneo; e forme di governo, invece, in cui è forte la prima e debole la seconda, come nel governo presidenziale statunitense, con il suo sistema di checks and balances.
Orbene, perché sarebbero moniste le forme di governo caratterizzate da debole separazione organica (e forte separazione funzionale) e dualiste, invece, quelle caratterizzate da forte separazione organica (e debole separazione funzionale)? Perché nelle prime è più forte la tendenza a consentire l’emergere di un potere unitario di direzione politica, mentre nelle seconde l’obiettivo è, quello opposto, di non consentire o perlomeno di rendere alquanto difficoltoso il concentrarsi della funzione unitaria d’indirizzo politico in un solo organo costituzionale. Volendo essere più precisi, i regimi parlamentari (razionalizzati in senso democratico) sono tendenzialmente monisti, mentre il regime presidenziale (americano) è tendenzialmente dualista.
Il fatto che il monismo e il dualismo siano (solo) obiettivi tendenziali cui mira la logica di fondo della forma di governo considerata e il cui grado di conseguimento può essere più o meno intenso, secondo le caratteristiche del sistema politico, dimostra di per sé che una forma di governo strutturata per funzionare in modo dualista può, in talune circostanze comportarsi in senso monista, e viceversa. In passato ho provato a spiegare questo fenomeno sovrapponendo al binomio monismo/dualismo il binomio formale/sostanziale e sostituendo così la bipartizione iniziale con una quadripartizione: da una parte il monismo con i due sottotipi formale e sostanziale, dall’altra il dualismo anch’esso con i due sottotipi formale e sostanziale[73].
Pertanto, in base al mio modello teorico nel sistema statunitense è sicuramente presente un dualismo formale, perché l’esecutivo e il legislativo godono di legittimazioni elettorali distinte e l’origine e la sopravvivenza di ciascuno non dipende dalla volontà dell’altro, realizzando così un regime di separazione organica dei poteri. Ma può essere presente anche un dualismo sostanziale, se questa separazione organica dei poteri (e separazione cronologica delle investiture elettive) determina una situazione di divided government, cioè la compresenza di indirizzi politici divaricati e, quindi, l’assenza di un potere unitario di direzione politica.
Il dualismo formale del governo presidenziale è dato dunque dalla pluralità dei canali elettivi, dal fatto cioè che più organi costituzionali sono eletti direttamente dal corpo elettorale, tra i quali di conseguenza s’instaura una reciproca separazione organica quanto alla loro origine e sopravvivenza[74]. Da meramente formale si tramuta in sostanziale quando, grazie pure allo sfasamento temporale delle tornate elettorali, si creano “maggioranze divise”, con una diversificazione degli orientamenti politici dei diversi organi costituzionali. Si ha perciò dualismo sostanziale quando manca un indirizzo politico unitario, perché il Congresso ne persegue uno diverso da quello presidenziale ovvero perché non perseguendone alcuno si limita a contrastarlo: per dirlo con la nota formula di Jones, separated institutions competing for sharing powers[75].
Il dualismo del governo presidenziale tende naturalmente verso il sottotipo sostanziale. Non per caso da trent’anni a questa parte il trend sembra decisamente questo. Tuttavia una forte stabilizzazione degli orientamenti politici e dei comportamenti elettorali può impedire questa evoluzione sostanziale e lasciare il dualismo a uno stadio solo formale. È quanto accadde, ad esempio, durante il New Deal roosveltiano, quando tutti i poteri costituzionali si trovarono ad agire di concerto secondo una linea politica condivisa e sotto la direzione politica unitaria del Presidente. In quella fase storica il governo presidenziale riuscì ad imprimere un indirizzo politico coeso, in grado di unificare l’azione di tutte le branches of government. Per usare la terminologia di un modello teorico diverso ma affine a quello qui adoperato, possiamo dire che allora l’«elemento costitutivo» del dualismo formale subì l’influsso dell’«elemento condizionante» costituito dal sistema politico-partitico[76].
Anche il monismo può conosce una declinazione (solo) formale ovvero (anche) sostanziale.
Il
primo caso è quello dei governi parlamentari in assetti multipartitici e
di «democrazia consensuale»[77].
Alla relazione fiduciaria tra parlamento e governo non corrisponde un raccordo
forte tra maggioranza parlamentare ed esecutivo, ed il secondo difficilmente
riesce ad operare come comitato direttivo della prima. Ciò si verifica
soprattutto nei sistemi che combinano pluripartitismo estremo, proporzionalismo
elettorale e profondi cleavages
ideologici o religiosi o etnici: in queste realtà la pluralità
delle identità partitiche, delle ascendenze ideali e delle appartenenze
particolari dissolve l’unitarietà dell’indirizzo politico,
che assurge così a figura mitica ed inafferrabile[78].
Il
monismo sostanziale invece si realizza nel parlamentarismo maggioritario, dove
la presenza di un potere unitario di direzione politica è resa possibile
dalla coesione interna del partito di governo (nei sistemi bipartitici come
quello inglese) o dalla stabilità e vincolatività programmatica
dell’accordo di coalizione (nei sistemi a multipartitismo moderato come
quello tedesco). Alla relazione fiduciaria si aggiunge così un continuum reale tra maggioranza
parlamentare ed esecutivo. Questi appaiono saldamente coesi da un flusso
decisionale che ha nel governo il centro propulsivo.
Insomma, se la competizione elettorale è bipartitica, il monismo formale del regime parlamentare può acquistare un connotato sostanziale e il suo funzionamento concreto compattarsi attorno ad un forte guida politica unitaria. Se invece il confronto politico-elettorale si svolge in un ambiente multipartitico e con scarsa chiarezza del quadro politico, il monismo può assottigliarsi e scarnificarsi, fino a raggiungere una caratterizzazione puramente formale: tanto che alla relazione fiduciaria tra Parlamento e Governo possono corrispondere esecutivi e formule di governo dalla incerta fisionomia politica[79]. Anche in questo caso i sottotipi formale e sostanziale segnalano l’effetto dell’incontro tra gli elementi costitutivi della forma di governo e gli elementi condizionanti localizzati nel sistema politico.
9. –Chiasmi
e incentivi
Una peculiarità del modello teorico che propongo è la sua struttura a chiasmo. È possibile infatti abbinare, da una parte, il dualismo formale al monismo sostanziale e, dall’altra, il dualismo sostanziale al monismo formale. In particolare il governo parlamentare che opera nella modalità del monismo formale è assimilabile al governo presidenziale che opera nella modalità del dualismo sostanziale (tanto più se il governo parlamentare s’inscrive in una forma di stato federale o in corso di federalizzazione): in entrambi i casi manca un indirizzo politico unitario. E viceversa, il governo parlamentare che opera nella modalità del monismo sostanziale è accomunabile al governo presidenziale che opera nella modalità del dualismo formale, perché in entrambi i casi c’è un potere di direzione politica unitaria, un’attività determinativa dei fini politici generali di tutto l’ordinamento.
Posto che il monismo puramente formale coinciderebbe col dualismo sostanziale, poiché entrambi descrivono l’assenza di un potere unitario e coeso di direzione politica, tuttavia va da sé che è difficile misurare con precisione quando si ha presenza ovvero assenza di un potere unitario di direzione politica. Quale indice soddisfacente, seppure assai approssimativo, può assumersi il grado di variabilità delle maggioranze parlamentari che di volta in volta approvano le deliberazioni proposte. Quanto più queste maggioranze varieranno tanto più sarà fondato descrivere il funzionamento concreto della forma di governo nei termini di un monismo puramente formale (se è un regime parlamentare) o di un dualismo sostanziale (se è un regime presidenziale). In modo speculare, quanto più le maggioranze parlamentari che approvano le deliberazioni proposte saranno stabili, tanto più sarà fondato pensare che la forma di governo operi secondo la modalità del monismo sostanziale (se è un regime parlamentare) ovvero secondo le modalità del dualismo puramente formale (se è un regime presidenziale).
In conclusione, nella loro declinazione puramente formale il monismo e il dualismo non denotano altro che un sistema d’incentivi. Che alla declinazione formale si accompagni quella sostanziale è perciò altamente probabile, ma non è certo. Si è fatto l’esempio del governo presidenziale: la forte separazione organica (e connessione funzionale) che lo caratterizza, cioè il dualismo formale, genera solitamente pure la dispersione del potere unitario di direzione politica, cioè il dualismo sostanziale. Ma in taluni momenti, per quanto siano rari, è accaduto che tale regime di separazione non impedisse l’emergere di una forte guida politica unitaria. Ciò a riprova che il dualismo (e il monismo) formale è solo un impulso affinché se ne produca uno sostanziale: ma per quanto potente, non è uno stimolo infallibile[80].
10. –Applicazione
I. La forma di governo della Quinta Repubblica francese
Anche solo per testarne la forza euristica, può essere interessante applicare questo sistema di classificazione alla forma di governo francese. Essa è monista o dualista? Per rispondere alla domanda occorre chiedersi se essa incentiva o disincentiva il formarsi di un potere unitario di direzione politica.
Finora si è dato praticamente per scontato che la previsione di un solo organo di rappresentanza elettiva denoti di per sé un assetto almeno formalmente monista. In altre parole, che un solo organo costituzionale (il parlamento) sia collegato direttamente con il corpo elettorale è un fatto che di per sé incentiva l’esercizio unitario della funzione d’indirizzo politico. Perlomeno più di quanto non sarebbe dato riscontrare nell’ipotesi in cui, invece, gli organi costituzionali collegati direttamente al corpo elettorale fossero almeno due. Si è detto però che in pratica questo incentivo può fallire, se il sistema politico è strutturato in modo tale da non assecondarne la logica; e di conseguenza questo monismo può rimanere solo sulla carta.
Tuttavia in questo caso voglio pormi una questione diversa, ossia chiedermi se la previsione di almeno due organi costituzionali elettivi sia, sempre e comunque, un fattore che rende formalmente dualistico l’assetto della forma di governo. Se considerata di per sé, è chiaro che tale previsione è un incentivo al dualismo sostanziale (ed è quindi un esempio di dualismo formale). Però bisogna chiedersi se tutto considerato può darsi il caso che invece non sia sufficiente a denotare un sistema costituzionale come formalmente dualistico. Può succedere infatti che la previsione di almeno due organi elettivi si accompagni ad altre previsioni la cui ratio sia invece quella di facilitare il formarsi di un potere unitario di direzione politica: e quindi non si può escludere che il naturale incentivo al dualismo sostanziale, costituito dalla previsione di due organi elettivi, possa essere neutralizzato da incentivi che invece spingono nella direzione opposta.
Quest’ultimo caso è quello che si riscontra nella forma di governo della Quinta Repubblica francese. Come nel sistema presidenziale americano ci sono (almeno) due organi costituzionali elettivi, l’Assemblea nazionale e il Presidente della Repubblica. Questo dato s’inserisce tuttavia in un contesto ordinamentale assai diverso da quello statunitense. Il Presidente condivide il potere esecutivo con un gabinetto che deve contare sul sostegno parlamentare: ciò significa quindi che il Presidente non può esprimere un gabinetto che sia sgradito al parlamento (come nel regime parlamentare dualista). Di contro può decretare unilateralmente lo scioglimento anticipato dell’assemblea elettiva (ma tra uno scioglimento e l’altro deve decorrere almeno un anno).
Tra Presidente e Assemblea c’è pertanto separazione organica per quanto riguarda l’origine, l’investitura dei due organi, ma c’è però una connessione (unilaterale) per quanto riguarda la sopravvivenza di uno dei due. O meglio, la costituzione francese garantisce una reciproca e netta separazione organica (quanto ad origine e sopravvivenza) solo per un anno, decorso il quale la sopravvivenza dell’Assemblea dipende dalla volontà unilaterale del Presidente (il quale – sempre che i sondaggi ne suggeriscano la praticabilità politica – può decidere liberamente d’interrompere la legislatura e disporre le elezioni parlamentari anticipate).
Sarebbe sufficiente questo per distanziare il modello francese dal dualismo formale del sistema americano. Ma c’è dell’altro. In USA la durata del mandato presidenziale è di 4 anni, la Camera dei rappresentanti viene rinnovata integralmente ogni 2 anni, mentre il Senato per 1/3 ogni due anni. La diversa durata dei mandati fa sì che solo in occasione delle elezioni presidenziali vi siano elezioni contestuali per il rinnovo degli altri organi costituzionali (ma il Senato solo per 1/3). Questo meccanismo di sfasamento temporale delle tornate elettorali è parte essenziale del dualismo formale predisposto dalla costituzione federale americana: la sua ratio è favorire il divided government e ostacolare perciò il formarsi di un potere unitario di direzione politica. Ebbene, in Francia niente di tutto questo è presente nella disciplina vigente. Con le riforme del 2000, infatti, la durata del mandato presidenziale viene ridotta da 7 a 5 anni, esattamente come il mandato parlamentare; e il calendario elettorale è stato invertito facendo precedere le elezioni parlamentari da quelle presidenziali, in modo che queste possano sortire un effetto di traino su quelle. L’obiettivo è chiaramente quello di ridurre fortemente, se non azzerare del tutto, la possibilità della cohabitation, ossia la possibilità di un dualismo sostanziale, di una dispersione del potere unitario di direzione politica[81].
A tutto questo devono aggiungersi i meccanismi di forte razionalizzazione del rapporto tra governo e attività parlamentare: il controllo governativo sull’ordine del giorno dell’Assemblea nazionale, la durata limitata delle sessioni parlamentari, il riparto delle competenze tra legge e regolamento (e la residualità a favore di quest’ultima fonte), il vote bloqué[82], la disciplina della questione di fiducia[83], ecc. Sono tutti istituti che risalgono al testo costituzionale del 1958 e la cui funzione d’imprimere una dinamica monista è esaltata vieppiù dall’introduzione dell’elezione diretta del Presidente. Insomma, non solo il vertice (fisiologico, salvo cohabitation) dell’esecutivo non è responsabile politicamente dinanzi all’Assemblea (in quanto eletto a suffragio universale diretto), ma inoltre il governo da lui presieduto e, in sostanza, guidato ha il controllo saldo delle attività parlamentari grazie ai congegni razionalizzanti elencati prima.
Quale conclusione può dunque trarsene? Che il programma della forma di governo vigente nella Francia contemporanea è quello del monismo formale: gli incentivi perché si traduca in un monismo sostanziale sono più potenti di quelli che, invece, favorirebbero l’assenza di un potere unitario d’indirizzo politico.
Ovviamente non si può escludere che il monismo rimanga solo formale. Ad esempio può succedere che: a) le elezioni presidenziali e quelle parlamentari diano un esito diverso, premiando formazioni politiche differenti; b) oppure che il Presidente faccia male i suoi calcoli politico-elettorali, sciogliendo avventatamente l’Assemblea e consegnando la vittoria elettorale al partito avverso (o alla coalizione partitica avversa). È difficile che queste due eventualità si realizzino, ma certo non possiamo escluderle del tutto.
Può succedere inoltre che, nonostante il senso suggerito dalla razionalizzazione impressa dalla riforma del 2000, il monismo formale dia sì vita a un monismo sostanziale, consegnando però il potere unitario di direzione politica non già nelle mani del Presidente ma in quelle del Primo ministro. Ciò è quanto potrebbe accadere se è il Primo ministro e non il Presidente il capo del partito che ha vinto sia le elezioni presidenziali che quelle parlamentari (o se è il leader del partito più forte all’interno della coalizione che ha vinto entrambe le elezioni). Ciò nondimeno anche in questo caso ci troviamo di fronte a un’eventualità possibile ma improbabile, perché non c’è dubbio che la carica presidenziale è politicamente più appetibile di quella di Primo ministro: tutte le attribuzioni di quest’ultimo non possono esercitarsi senza il consenso dell’altro, ma non vale il reciproco, perché ci sono numerose attribuzioni presidenziali, peraltro assai significative, che possono esercitarsi senza il consenso del Primo ministro[84]. Per non parlare del fatto che sulla testa del Primo ministro pende pur sempre la spada di Damocle della sfiducia parlamentare, mentre il Presidente è irresponsabile. A conti fatti, dunque, per il capo del partito (o della coalizione) è più naturale candidarsi alla carica presidenziale che non a quella di Primo ministro, con ciò rendendo alquanto improbabile che il monismo sostanziale si realizzi in corrispondenza di organi costituzionali diversi dal Presidente.
11. –Applicazione
II. La forma di governo delle regioni italiane
Un altro banco di prova per il criterio classificatorio che propongo è la forma di governo vigente nelle regioni italiane: è dualista o monista?
Abbiamo visto che nell’attuale forma di governo francese la previsione di due organi costituzionali eletti a suffragio universale diretto non è, di per sé, sufficiente a collocarla tra gli assetti dualisti, perché nella disciplina costituzionale complessiva vi sono istituti che determinano un forte monismo formale: gli incentivi perché si formi un potere unitario di direzione politica (cioè un monismo sostanziale) sono di gran lunga più numerosi e potenti di quelli che vanno nella direzione opposta. Ciò nondimeno, considerata di per sé, la previsione di due distinti organi elettivi è senza dubbio un elemento di dualismo formale, soprattutto se hanno un mandato di durata diversa, con sfasamento cronologico delle tornate elettorali, e se vi è un rapporto di separazione organica quanto ad origine e sopravvivenza di ciascuno.
Orbene, nella forma di governo vigente nelle regioni italiane la previsione di due organi parimenti elettivi – il Presidente e il Consiglio – non si accompagna né alla separazione temporale dei rispettivi momenti elettorali, né alla separazione reciproca quanto alla loro origine e sopravvivenza: in effetti la formula del simul stabunt simul cadent parrebbe suggerire proprio la forte connessione organica tra esecutivo e legislativo sia per quanto riguarda la loro investitura, sia per quanto concerne la loro permanenza in carica. Da una parte il meccanismo dell’elezione contestuale del Presidente e del Consiglio (unito a un sistema elettorale che contempla un premio di maggioranza per la lista o coalizione di liste collegata al Presidente eletto) assicura il collegamento della loro origine; dall’altra la disciplina degli effetti delle dimissioni presidenziali e dell’approvazione della mozione di sfiducia (eventi che determinano in entrambi i casi lo scioglimento anticipato del Consiglio) assicura a ciascuno dei due organi il potere di decidere sulla sopravvivenza dell’altro (con effetti automatici pure sulla propria).
Per tutta questa serie di ragioni la Corte costituzionale, nella sentenza n. 12 del 2006, scrive che «non esiste tra Presidente della Giunta e Consiglio regionale una relazione fiduciaria assimilabile a quella tipica delle forme di governo parlamentari, ma un rapporto di consonanza politica, istituito direttamente dagli elettori, la cui cessazione può essere ufficialmente dichiarata sia dal Presidente che dal Consiglio». Questa «presunzione di consonanza politica» tra Presidente e Consiglio testimonia che lo scopo cui mira la forma di governo regionale è realizzare una condizione di forte omogeneità tra l’indirizzo politico presidenziale e quello consiliare. Sembrerebbe dunque che tale assetto sia tra quanto di più lontano possa esserci dal modello dualista americano. Non per caso è diffusamente chiamata «forma di governo neo-parlamentare» e, nelle intenzioni di coloro che l’hanno progettata e voluta, nasce come il tentativo di ricreare artificialmente le regolarità politiche del sistema britannico, che è un esempio paradigmatico di monismo sostanziale.
Sennonché è intervenuto un fenomeno d’eterogenesi dei fini e, a un’analisi più attenta, risulta che la logica sistemica di questa forma di governo sia diversa da quella voluta o da quelle che si credeva di progettare. Si è detto che, diversamente dal modello americano, nel modello esaminato ci sarebbe una forte connessione organica tra esecutivo e legislativo sia per quanto riguarda la loro origine, sia per quanto riguarda la loro sopravvivenza. In realtà questa è solo un’illusione ottica. Vediamo perché.
Separazione nell’origine significa che, dati due organi, nessuno dei due deriva la propria investitura dalla volontà dell’altro: è precisamente il caso del rapporto tra esecutivo e legislativo nel sistema statunitense. Il contrario dovrebbe perciò realizzarsi quando l’investitura di uno dipende dalla volontà dell’altro, come nei sistemi parlamentari, dove il governo deve godere della fiducia del parlamento (espressa o presunta che sia). Nel caso della forma di governo regionale, dunque, non si ha il contrario del modello separazionista americano, perché né l’esecutivo trae la propria investitura dal legislativo, né il legislativo dall’esecutivo, ma entrambi la traggono direttamente dal corpo elettorale, come per l’appunto nel sistema americano. Certo, l’elezione è pur sempre contestuale (e c’è pure il premio di maggioranza): però questa circostanza non può intendersi come una forma di connessione nell’origine, diretta a realizzare il contrario della separazione nell’origine. L’esatto contrario di quest’ultima è, infatti, solo l’istituto dell’investitura parlamentare dell’esecutivo.
Inoltre neanche è possibile ritenere che la forma di governo in esame realizzi il contrario della separazione tra esecutivo e legislativo per quanto riguarda la loro sopravvivenza, sebbene il principio del simul stabunt simul cadent sembrerebbe esattamente preordinato a tale fine. La separazione quanto a sopravvivenza sta a indicare che la permanenza in carica di un organo non dipende dalla volontà dell’altro, ma solo dal decorso integrale della durata fissa del mandato. Il contrario di questa logica è pertanto quella che informa i sistemi parlamentari, dove il parlamento può sfiduciare il governo. Ebbene, in tanto ha senso affermare che la sopravvivenza di un organo (il governo) dipende dalla volontà dell’altro (il parlamento), in quanto il rapporto tra i due non sia egualitario ma gerarchicamente ordinato in modo tale che chi decide d’interrompere la permanenza in carica dell’altro non interrompa automaticamente pure la propria. In effetti, nei sistemi parlamentari all’approvazione della mozione di sfiducia non segue automaticamente lo scioglimento del parlamento: e ciò neppure nei sistemi fortemente razionalizzati dove il ruolo del capo dello stato è praticamente nullo (come in Germania).
Ciò premesso e precisato, cosa accade se al potere del parlamento di sfiduciare il governo si aggiunge, quale effetto automatico e necessario, lo scioglimento anticipato dell’assemblea e se si attribuisce un eguale potere, con eguale effetto automatico e necessario, al governo nei confronti del parlamento? Avremo veramente il contrario dell’americana separazione quanto a origine e sopravvivenza? Nient’affatto, perché – per effetto del c.d. «equilibrio del terrore»[85] – i due istituti della sfiducia e dello scioglimento tenderanno ad azzerarsi reciprocamente come effetto di una somma algebrica tra numeri uguali ma di segno opposto[86].
In sostanza il risultato non sarà un monismo formale del tipo di quello affermato dal modello francese vigente, dove il Presidente non solo controlla, attraverso il suo gabinetto, le attività parlamentari grazie a efficaci meccanismi di razionalizzazione, ma può anche sciogliere il parlamento senza mettere a repentaglio la propria permanenza in carica. Nel modello regionale vigente, invece, il Presidente non dispone di alcuna vera risorsa per costringere il Consiglio ad assecondare il suo indirizzo, perché la minaccia dello scioglimento è in realtà pure una minaccia rivolta a sé stesso[87]. Viceversa, neppure il Consiglio dispone di alcuna vera risorsa per indirizzare l’attività della Giunta, poiché – anche in questo caso – la minaccia della sfiducia è pure una minaccia rivolta contro sé stessi.
In conclusione, a dispetto delle apparenze, questa forma di governo non contempla veri incentivi affinché vi sia un continuum effettivo tra maggioranza consiliare e Giunta, ed anzi – costruendo il rapporto tra i due organi come se fossero perfettamente paritari – crea un ambiente propizio perché possano convivere per lungo tempo (finanche per l’intera durata della legislatura) indirizzi politici divaricati tra assemblea elettiva e governo[88]. È più corretto dunque ascrivere questa forma di governo tra quelle di tipo dualista.
Ciò non toglie, ovviamente, che il dualismo formale della costituzione federale americana è più accentuato di quello che qui attribuisco alla forma di governo delle regioni italiane. Così come il monismo formale che caratterizza il modello francese vigente è più pronunciato di quello che in genere informa i regimi parlamentari odierni, ivi compresi quelli fortemente razionalizzati. Ciò significa che l’incentivo affinché si determini un dualismo sostanziale è più forte in USA di quanto lo sia nel modello regionale italiano. E analogamente l’incentivo affinché si determini un monismo sostanziale è più forte in Francia di quanto lo sia nella forma di governo nazionale italiana.
12. –Il
monismo nel parlamentarismo razionalizzato
Come già ho precisato, i termini “monismo” e “dualismo” indicano solo dei punti d’orientamento, che consentono livelli diversi di approssimazione. Rimane fermo perciò che il monismo sostanziale, cioè l’unitarietà dell’indirizzo politico, è una condizione del potere pubblico che nella sua pienezza può trovare realizzazione solo laddove ci fosse «il comando di uno solo». La ricerca storica ha però dimostrato che neppure nelle monarchie assolute fu possibile raggiungere questo risultato. Dunque o non esistono o sono rarissimi gli ordinamenti dove una sola volontà riesce a concentrare su di sé la direzione politica generale. Piuttosto ci sono ordinamenti più o meno orientati verso una condizione di questo tipo, ma nessuno che l’abbia espressa al massimo grado.
Lo stesso vale per il dualismo sostanziale. Il grado di dispersione del potere pubblico può variare parecchio, fino a coincidere nel suo grado massimo con l’assenza di un ordinamento unitario. E nel suo grado minimo con l’unitarietà del potere, cioè col monismo sostanziale. Monismo e dualismo sono pertanto i due estremi di un medesimo segmento, lungo il quale possiamo collocare le diverse esperienze conosciute per valutare in modo comparativo il grado di accentramento e dispersione di potere che incentivano e che effettivamente realizzano. Non avrebbe senso quindi asserire che una data esperienza è in assoluto monista ovvero dualista, perché ciò dipende sempre dal raffronto con altre esperienze. Il governo presidenziale non è dualista di per sé, ma lo è in relazione al governo parlamentare. E questo a sua volta non è monista di per sé, ma lo è in relazione al governo presidenziale.
Da quanto premesso si deduce che, rimanendo nell’ambito delle forme di governo parlamentare, esistono assetti più o meno monisti (sia sotto il profilo formale che sostanziale). Si descrive il medesimo fenomeno quando si distingue tra regimi parlamentari ad alta e bassa razionalizzazione.
Anzitutto va detto che il monismo formale è divenuto un elemento costitutivo costante di tutti i regimi parlamentari grazie precisamente alla «razionalizzazione (democratica) del potere»[89]. In seguito al sopravvento definitivo del principio democratico-parlamentare sul principio monarchico solo il potere politico basato sulla rappresentanza elettiva è riconosciuto come legittimo. E se il canale dell’investitura elettiva è unico – la rappresentanza parlamentare – si avrà di conseguenza il monismo formale del parlamentarismo razionalizzato.
C’è quindi un nesso stretto tra il processo di democratizzazione delle esperienze costituzionali europee e il fenomeno della «razionalizzazione del potere». Democratizzare le istituzioni europee non poteva significare altro che spostare definitivamente il baricentro della direzione politica statale sulla rappresentanza elettiva. Per fare questo fu necessario rimuovere il vecchio principio della doppia fiducia del gabinetto sia nei confronti del re che nei confronti della camera elettiva (principio che era tipico del regime parlamentare classico o dualista); e sostituirlo col nuovo principio della fiducia del gabinetto solo nei confronti della rappresentanza elettiva (principio che appunto segna il passaggio al parlamentarismo razionalizzato, cioè ormai compiutamente democratico). Razionalizzare il parlamentarismo in senso democratico significò dunque eliminare il ruolo politico del capo dello stato (cioè del re) e sostituire il dualismo dei centri di direzione politica dello stato (la corona e il parlamento) col monismo formale del raccordo fiduciario tra parlamento e gabinetto[90].
Il nesso tra democratizzazione delle istituzioni costituzionali, formalizzazione del rapporto fiduciario di responsabilità politica tra gabinetto e parlamento, ridimensionamento del ruolo politico del capo dello stato e approdo conseguente a una logica di tipo monista non esaurisce, tuttavia, il significato complesso del fenomeno della «razionalizzazione del potere». Mirkine-Guetzevitch sottolinea che il «parlamentarismo razionalizzato» è anche «il tentativo di regolare la stabilità governativa», cioè «la lotta contro l’instabilità ministeriale»[91].
Sotto questo profilo, anche se la cosa pare sfiorare il paradosso, «il sistema inglese non differisce punto dal parlamentarismo razionalizzato del secolo XX»[92]: per certi versi quest’ultimo è (anche) il tentativo di ricreare artificialmente, per mezzo d’incentivi costituzionali, una regolarità politica che nel modello Westminster si è prodotta spontaneamente, cioè in assenza di qualsiasi razionalizzazione.
Ricapitolando: la razionalizzazione del governo parlamentare è l’introduzione del monismo formale; e a sua volta questo monismo formale non solo testimonia la compiuta democratizzazione dell’assetto costituzionale, ma inoltre costituisce il tentativo più o meno intenso d’indurre la formazione di un potere unitario di direzione politica, attraverso la garanzia della stabilità governativa. L’introduzione del monismo formale può infatti registrare declinazioni diverse. Abbiamo esperienze ad alta razionalizzazione ed esperienze a bassa razionalizzazione.
Nelle prime è più decisa la volontà che al monismo formale ne corrisponda pure uno sostanziale: difatti contempla incentivi istituzionali potenti in vista di quest’esito. Nelle seconde invece sono pressoché assenti accorgimenti istituzionali che, in aggiunta al principio della responsabilità politica del gabinetto di fronte alle camere, siano diretti ad assicurare il formarsi di un potere unitario di direzione politica che controlli saldamente il raccordo tra governo e maggioranza parlamentare.
Ora, se si guarda all’esperienza tedesca odierna di parlamentarismo fortemente razionalizzato, può osservarsi chiaramente come l’introduzione di tali accorgimenti istituzionali e incentivi costituzionali corrisponda a una drastica riduzione, se non completa eliminazione, di qualsiasi ruolo politico in capo al presidente della repubblica. Con ciò dimostrando che in tanto può dispiegarsi un coerente monismo sostanziale (oltre che formale) nei rapporti tra governo e parlamento, in quanto si riducano le attribuzioni del capo dello stato a funzioni meramente notarili se non simboliche.
Non per caso, quale esempio di spiccata razionalizzazione, il Grundgesetz ridimensiona drasticamente i due poteri tradizionali del capo di stato parlamentare: ossia il potere di nomina del gabinetto e il potere di dissoluzione anticipata del parlamento. Il primo, infatti, è sostanzialmente sostituito dall’elezione parlamentare del Cancelliere (artt. 63-64 GG) e, soprattutto, dall’istituto della sfiducia costruttiva (art. 67 GG), che di fatto elimina il ruolo politicamente importante del capo di stato nella risoluzione delle crisi di gabinetto. Il secondo – cioè il potere di scioglimento – è tassativamente legato al verificarsi di condizioni tipiche, le quali lasciano in capo al Presidente federale un margine di valutazione praticamente inesistente[93].
Come si vede, l’obiettivo della razionalizzazione operata dal sistema tedesco è non solo quello di assicurare la stabilita governativa, ma anche quello di circoscrivere la dinamica politica federale dentro il raccordo tra maggioranza parlamentare e governo, riducendo al minimo gli apporti di attori costituzionali “terzi”. Il rafforzamento del potere unitario di direzione politica, cioè la garanzia della stabilità governativa, e il depotenziamento sensibile delle funzioni del capo dello stato sono le due facce di una stessa medaglia[94].
Se tutto questo è corretto, come dobbiamo classificare allora la forma di governo italiana, notoriamente collocata tra quella a bassa razionalizzazione? È anch’essa un esempio di monismo formale oppure occorre una valutazione più sfumata?
13. – La “terza via” della
repubblica parlamentare italiana
Non c’è alcun dubbio che il governo parlamentare della Repubblica italiana appartiene al tipo razionalizzato e che pertanto prevede un assetto di monismo formale: non c’è, infatti, il principio della doppia fiducia e la legittimazione del potere politico passa attraverso il solo canale della rappresentanza elettiva, creando un rapporto di connessione e dipendenza organica tra Parlamento e Governo.
Questa razionalizzazione del rapporto tra esecutivo e legislativo è però debole, perchè «si riduce a regolamentare soprattutto la mozione di sfiducia e non adotta adeguati meccanismi volti a garantire la stabilità del Governo»[95]. E questo nonostante in Assemblea costituente l’ordine del giorno Perassi sottolineasse la necessità di adottare «dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo».
La debolezza della razionalizzazione italiana emerge inoltre dalla posizione e dal ruolo che la Costituzione assegna al PdR. La sua fisionomia non è riducibile né a quella di un monarca parlamentare, né a quella del Presidente federale tedesco, nonostante sia il Presidente italiano che quello tedesco ricevano ambedue un’investitura parlamentare. A rigor di concetto, l’investitura parlamentare del capo dello stato, isolatamente considerata, non è un dato dal quale possono trarsi elementi risolutivi riguardo al peso del capo dello stato nella forma di governo: bisogna infatti vedere se si accompagna al riconoscimento di rilevanti attribuzioni. Orbene, le attribuzioni del PdR italiano non sono certo limitate quanto quelle del Presidente federale tedesco: essi perciò non differiscono granché sotto il profilo strutturale delle modalità attraverso le quali sono preposti nella carica, ma divergono radicalmente sotto il profilo funzionale delle competenze attribuite.
Se ne deve perciò concludere che in Italia il circuito dell’indirizzo politico nazionale, che prende l’avvio dalla sovranità popolare, non si risolve interamente nel circuito popolo-parlamento-governo, caratterizzando in modo intensamente monista il nostro regime parlamentare. Alla luce del dato funzionale e strutturale, ossia considerando la tesi dell’atto presidenziale come atto complesso e il fondamento alfine democratico-parlamentare della carica presidenziale (che rende la sua posizione costituzionale assai differente rispetto a quella del monarca parlamentare), bisogna alfine ricostruire il circuito dell’indirizzo politico nazionale nel modo che segue:
Popolo → Parlamento → Presidente
della Repubblica e Governo
Da un lato, il fatto che l’investitura del capo dello stato non sia dinastico-tradizionale, ma “parlamentare integrata”, non consente di appiattire il ruolo del nostro PdR su quello del re nelle monarchie parlamentari esistenti; dall’altro lato, il fatto che la detta investitura elettiva non sia propriamente di secondo grado ma solo genericamente indiretta, non consente di assimilare il nostro regime parlamentare al dualismo netto del regime presidenziale statunitense[96].
Da quanto osservato si ricava che il nostro PdR non può certo essere un veto player rispetto al parlamento[97]; e segnatamente non può esserlo rispetto alla funzione legislativa ordinaria[98]. Può esserlo invece nei confronti del Governo, come risulta sia dalla dottrina dell’atto complesso, sia dal fatto che la legittimazione democratica del PdR non è certo inferiore a quella del gabinetto, come già si è detto.
Per chiarire meglio il concetto può essere utile adoperare come cartina di tornasole la nota tesi di Jones secondo cui esistono assetti costituzionali dove «separated institutions competing for shared powers»: dove, cioè, organi distinti e provvisti di distinte legittimazioni (democratiche) competono tra loro per esercitare poteri condivisi[99]. È notorio che questa formula è stata coniata con riferimento alla costituzione federale americana e per descrivere soprattutto i rapporti tra President, House of Representatives e Senate. Ma in un certo senso può impiegarsi anche per la nostra forma di governo, limitatamente però al rapporto tra Governo e PdR. In virtù, infatti, di quanto si è scritto sinora con riguardo alla dottrina dell’atto complesso, tutti i poteri del PdR – per effetto della necessaria controfirma del ministro proponente – sono anche poteri del Governo; e viceversa, tutti i poteri del Governo, avendo essi sempre la forma dell’atto presidenziale, sono sempre anche poteri del capo dello stato. Abbiamo quindi organi distinti, con un mandato temporalmente distinto e ciascuno provvisto di una propria distinta legittimazione democratico-parlamentare, i quali condividono le medesime funzioni e che perciò possono legittimamente competere tra loro per piegarne l’esercizio a interessi politici differenti.
Grazie alle virtualità insite nel ruolo presidenziale (per come risulta dalla ricostruzione del disegno costituzionale proposta in queste pagine), non abbiamo il dualismo americano tra esecutivo e legislativo, ma non abbiamo neppure il tipo di monismo formale che invece ci viene tradizionalmente attribuito. Abbiamo invece una sorta di “terza via” tra la repubblica presidenziale (statunitense) e la monarchia parlamentare (contemporanea).
Non c’è dualismo tra governo e parlamento, ma non c’è neppure integrale dipendenza dell’esecutivo dal legislativo, perché in realtà – almeno dal punto di vista funzionale se non strutturale e organico – abbiamo un esecutivo diviso, di cui solo un’articolazione funzionale, quella che mette capo al gabinetto, è responsabile politicamente dinanzi alle Camere. L’altra branca, quella costituita dal PdR, non dipende per la sua sopravvivenza dal consenso di una maggioranza parlamentare. D’altro canto, però, non può mai agire da sola, cioè in modo potenzialmente idoneo ad entrare in conflitto con l’indirizzo parlamentare, ma sempre e soltanto con l’accordo del Governo. Con riferimento alle funzioni presidenzial-governative il capo dello stato e il gabinetto sono ciascuno il potenziale veto player dell’altro: separated institutions competing for shared powers, appunto[100].
È dunque impensabile una politica presidenziale attiva che non sia anche e nello stesso tempo una politica governativa politicamente responsabile di fronte alle Camere. Non c’è dubbio che l’atto presidenziale sia esercizio di potestas: ma lo è proprio perché è un atto complesso, cioè presidenziale e governativo ad un tempo. L’indirizzo politico del PdR è perciò manifestazione di potestas nella misura in cui converge con quello del Governo. È invece manifestazione di auctoritas quando se ne discosta e assume un profilo non già attivo bensì negativo, ossia quando si palesa come volontà di non fare e quindi di frenare e impedire che si faccia[101].
Ovviamente non si può escludere che i detti poteri d’interdizione reciproca rimangano quiescenti e che col tempo si affermino delle convenzioni che graduino il ruolo di ciascuno dei due organi nella determinazione del contenuto dell’atto o che, addirittura, ne assegnino la relativa competenza ad uno solo di essi. Poiché le caratteristiche del sistema partitico, e più in generale politico, e i rapporti di forza tra gli attori costituzionali possono variare nel tempo, può ben accadere che negli svolgimenti della prassi il modello dell’atto complesso, in taluni ipotesi, ceda il passo al modello dell’atto “semplice” (ora sostanzialmente governativo, ora sostanzialmente presidenziale).
Ciò non deve sorprendere, né tantomeno ingenerare il convincimento che ci si trovi dinanzi a violazioni della Costituzione[102]. Un potere previsto dalla Costituzione può esercitarsi oppure no, secondo il libero apprezzamento di chi di volta in volta n’è il titolare: ciò che conta è che il suo eventuale esercizio, laddove fosse anche rarissimo, non sia ritenuto illegittimo alla luce di prassi e convenzioni che fino a quel momento andavano in direzione opposta. Mutuando la terminologia di Albert Venn Dicey, occorre distinguere tra conventions of the Constitution e law of the Constitution, onde evitare che le prime possano sopraffare il secondo per sostituirsi ad esso[103].