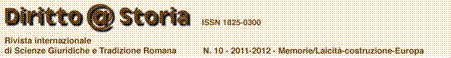Università di Roma “La Sapienza”
Sacerdoti
e magistrati nel diritto pubblico romano*
SOMMARIO: 1. Relazione tra
sacerdoti e magistrati nella dottrina contemporanea. – 2. La cosiddetta “laicizzazione” del diritto.
– 3. La distinzione tra sacerdoti e magistrati
nelle fonti. – 4. L’introduzione
del principio elettorale nella scelta dei sacerdoti. – 5. La cooptazione. – 6. La
partizione del diritto pubblico romano, dalla repubblica all’età
imperiale fino a Giustiniano.
1. – Relazione tra sacerdoti e magistrati nella dottrina
contemporanea
La relazione tra sacerdoti e magistrati
costituisce uno degli aspetti della più generale relazione tra religione
e diritto. Essa è stata esaminata in vario modo dagli studiosi, e non si
può dire, ad oggi, che siano state raggiunte conclusioni esaurienti.
Tra il 1874 ed il 1875, Mommsen[1]
affermava che «wenn in Rom anfänglich in der Person des Königs
Amt und Priesterthum zur Einheit verschmolzen gewesen sind, so ist zwischen der
Magistratur und dem Priesterthum der Republik die Grenzlinie mit römischer
Schärfe gezogen». Lo studioso tedesco individuava
una “Grenzlinie”
tra i sacerdozi e le magistrature e ne collocava l’origine
all’inizio dell’età repubblicana.
Nel passaggio tra la monarchia e la
repubblica sarebbe stata avvertita la necessità di attribuire ad un solo
sacerdote maggiori poteri rispetto agli altri, affinché questi avesse la
guida suprema dei sacerdotes:
«das Ergebniss davon ist die Einsetzung eines eigenen mit Auspicium und Imperium ausgestatteten und dem König lebenslänglichen und
unabsetzbaren sacralen Oberen, des Pontifex
maximus». Lo stesso
Mommsen, però, dopo poche pagine, trovava il modo di attenuare le sue
conclusioni riguardo all’imperium; affrontando la questione
relativa ai poteri necessari per riunire i comitia pontificis maximi
(che erano tenuti da uno dei pontefici «als stellvertretender
Oberpontifex»), dopo aver sostenuto che questi comizi «müssen auspicato
stattgefunden haben», affermava che essi «sind ohne eine dem
Imperium analoge Gewalt nicht denkbar». In conclusione, il pontefice massimo non
era un magistrato, ma possedeva poteri da magistrato (lo studioso tedesco
elencava auspicium ed imperium o «eine dem Imperium analoge
Gewalt»); infatti, la prima parte del secondo volume di Römisches
Staatsrecht era intitolata da Mommsen “Die magistratische
Befugniss des Oberpontifex” (la versione francese traduceva “Les
pouvoirs de magistrat du grand pontife”).
Nel 1915 uno studioso italiano, Ettore
Pais, criticando Mommsen e la pretesa separazione tra sacerdozi e magistrature
nell’età repubblicana, sosteneva che le “funzioni” dei sacerdoti e quelle dei magistrati si
incrociavano, costituendo una caratteristica fondamentale dello “Stato
romano”: «a Roma si
mantennero chiare le tracce di un governo in cui l’elemento sacerdotale
era non meno vigoroso di quello militare. (...) I due elementi furono così poco separati e distinti che il
pontefice massimo, il flamine Diale e il Marziale continuarono a far parte del
Senato. L’elemento religioso
serbò parte così notevole nel Governo, che i magistrati civili
nulla potevano compiere senza una precedente osservanza degli auspici ed una
espiazione dei prodigi per mezzo dei pontefici. E la necessità di interpretare
prima il volere degli Dei per mezzo del volo degli uccelli sta in perfetta
correlazione col concetto che per molto tempo reputò necessaria la patrum
auctoritas prima di procedere alla rogazione di una legge davanti al popolo»[2].
Nonostante la
profonda differenza, la tesi di Mommsen e quella di Pais si incontrano quanto ai
caratteri che distinguono la figura del pontifex
maximus. La conclusione su cui convergono Mommsen e
Pais è che il pontifex maximus è
provvisto di imperium (o, per lo studioso tedesco, di «eine
dem Imperium analoge Gewalt»),
con questa differenza: Mommsen attribuisce
al solo pontefice massimo poteri analoghi a quelli dei magistrati, come una
sorta di eccezione alla collocazione su piani distinti di sacerdozi e
magistrature da lui teorizzata; Pais, invece, osservando che «i sacerdozi
erano coperti da quelle medesime persone che occupavano le sedie curuli»
e sostenendo che «le funzioni dei sacerdoti non vennero mai interamente
distinte da quelle dei magistrati», perviene alla conclusione che il
pontefice massimo aveva una certa giurisdizione non solo su sacerdoti, ma anche
«su qualunque magistrato civile».
Successivamente,
solo pochi autori hanno aderito alla tesi di Mommsen sull’imperium
del pontefice massimo; come pochi sono coloro che hanno seguito la tesi di Pais
sull’“incrocio” tra sacerdozi e magistrature. Forse è proprio
l’esiguità del numero di questi studiosi che ha condizionato la
quasi totalità della critica moderna, non facendole avvertire la
necessità di approfondire i caratteri fondanti della
“Grenzlinie”.
Così, la maggiore sensibilità per i contenuti del potere
del pontefice massimo ha portato gran parte della dottrina più recente
ad interessarsi della intensità dei poteri sacerdotali e somiglianza con
i magistrati invece che dei loro diversi fondamenti[3].
2. – La
cosiddetta “laicizzazione” del diritto
A) La dottrina
Il problema principale nello studio della
relazione tra religione e diritto, quindi, è costituito dalla polisemia
del termine “laicità” (dunque, dalla sua ambiguità) e
dall’uso, spesso acritico, fattone dai giuristi odierni per spiegare
questa relazione anche nel mondo antico[4]. Ora, non è mia intenzione
procedere ad una ricognizione degli studi sulla relazione tra religione e
diritto; mi limiterò ad esaminarne brevemente pochi, esemplari aspetti.
Max Weber sostenne che il rapporto tra
religione e sistemi giuridici sarebbe stato da sempre caratterizzato da due
processi: «Entzauberung» ed «Entgöttlichung»[5].
Fritz Schulz, nel 1934 e nel 1946, sostenne
che il rapporto tra «das geistliche und das weltliche Recht»
sarebbe stato caratterizzato dal passaggio da «Sonderung» a
«Isolierung» a partire dal III secolo a.C., quando la
giurisprudenza romana avrebbe subito un processo di “laicizzazione”,
per effetto del quale i giuristi non appartenevano più necessariamente
ad un collegio sacerdotale[6].
Weber e Schulz hanno avuto e tuttora hanno
tanta influenza sugli studi romanistici; ma spesso le loro teorie sono state
portate a conseguenze estreme. Su
queste basi, infatti, si è giunti successivamente a teorizzare la
“laicizzazione” del diritto stesso[7].
Eppure, dalle fonti emerge una maggiore complessità
per ciò che concerne la relazione tra religione e diritto.
B) Le fonti
In un passo tratto dall’opera di Aulo
Gellio appare che il diritto pontificio
ed il diritto augurale sono studiati anche da chi non è sacerdote[8]. Ebbene come si può
interpretare questo testo, se si procede dalla
prospettiva della “laicizzazione della giurisprudenza” intesa quale
presupposto della “laicizzazione” del diritto? Forse che anche il
diritto pontificio ed il diritto augurale sarebbero stati
“laicizzati”? [9]
Ed
altresì, procedendo dalla medesima prospettiva, come si può
interpretare il passo del giurista Ulpiano,
in cui è evidente la stretta relazione, per la giurisprudenza, tra la
conoscenza delle cose divine e la conoscenza delle cose umane? [10]
Peraltro, nel passo del primo libro del
Digesto in cui il giurista Pomponio tratta della storia del diritto,
l’attività dei giuristi pontefici è definita
“scienza”, al pari di quella dei giuristi cosiddetti
“laici”[11].
Infine il potere di prendere auspici
è massimamente diffuso, in quanto gli auspici appartengono ad ogni
cittadino.
Nel
sistema romano, pertanto, il diritto non è separato né isolato
dalla religione; così, l’utilizzazione di termini e concetti
moderni (quali laico, laicismo, laicità, laicizzazione) per spiegare la
relazione tra religione e diritto nella Roma antica è frutto di
“autoproiezioni” concettuali e conduce a contraddizioni.
3. – La distinzione
tra sacerdoti e magistrati nelle fonti
La base testuale sulla quale Mommsen
fondava la sua tesi sull’imperium
del pontefice massimo è costituita da un passo di Livio, in cui è
narrato un conflitto tra il pontefice massimo Licinio ed il flamen Quirinalis e praetor Fabio Pittore, i quali avrebbero opposto l’uno
all’altro il loro imperium:
priusquam
in prouincias praetores irent, certamen inter P. Licinium pontificem maximum
fuit et Q. Fabium Pictorem flaminem Quirinalem, quale patrum memoria inter L.
Metellum et Postumium Albinum fuerat. consulem illum cum C. Lutatio collega in
Siciliam ad classem proficiscentem ad sacra retinuerat Metellus, pontifex
maximus; praetorem hunc, ne in Sardiniam proficisceretur, P. Licinius tenuit.
et in senatu et ad populum magnis contentionibus certatum, et imperia
inhibita ultro citroque, et pignera capta, et multae dictae, et tribuni
appellati, et prouocatum ad populum est. religio ad postremum uicit; ut dicto
audiens esset flamen pontifici iussus; et multa iussu populi ei remissa[12].
Il
fatto che il conflitto tra i due personaggi viene presentato da Livio in
termini di opposizione di poteri, proverebbe che il pontefice massimo abbia
l’imperium proprio dei
magistrati. Ma è provato che
Livio spesso utilizza la parola imperium
in modo improprio, intendendo in verità indicare più
genericamente potestas.
Questo fa maturare la convinzione che non
vi sono fonti attraverso le quali sia possibile dimostrare che il pontefice
massimo ed anche altri sacerdoti avessero poteri analoghi a quelli dei
magistrati[13].
Ma ciò non significa che sacerdozi e magistrature fossero tra loro
separati o isolati; del resto, Cicerone affermava chiaramente che le medesime
persone presiedevano alla religione ed al governo della res publica[14].
Inoltre, nella religione politeista dei Romani i singoli
cittadini, i magistrati ed i sacerdoti avevano auspicia, considerati una proiezione dei poteri umani sul piano del
diritto divino; nessuno, quindi, aveva l’esclusività della
consultazione della volontà divina.
Allora, se religione e diritto non erano
separati o isolati, e se la medesima persona poteva contemporaneamente
rivestire sia la carica di sacerdote sia la carica di magistrato, come si
rapportavano tra loro poteri sacerdotali e poteri magistratuali?
A) Magistrati
I magistrati sono eletti dal popolo
organizzato nei comizi. Gli stessi poteri dei magistrati hanno fondamento nel
popolo che li ha eletti, come emerge chiaramente da un testo di Cicerone:
omnes potestates, imperia,
curationes ab universo populo Romano proficisci convenit[15].
In questo testo è evidente che i
poteri possono essere attribuiti ai magistrati solo dal popolo intero,
cioè nella interezza delle parti che lo compongono.
Secondo la celebre definizione di Cicerone,
«populus ... coetus multitudinis iuris consensu et
utilitatis communione sociatus»[16].
Da questo testo emerge una concezione concreta del popolo. Popolo è,
pertanto, un termine che indica un’unità complessa composta di
parti; e le parti sono: i cittadini, gli ordini (ad esempio patrizi e plebei),
le centurie e le tribù, cioè le unità di voto,
rispettivamente, dei comizi centuriati e dei comizi tributi.
Con il termine
‘popolo’, quindi, le fonti indicano concretamente l’insieme
dei cittadini che, per esprimere la propria volontà, sono organizzati
nei comizi, riuniti per eleggere i magistrati ovvero per approvare le leggi
rogate dai magistrati. Infatti, la legge è definita pubblica
perché proviene dal popolo; allo stesso modo, i magistrati sono detti
pubblici perché sono eletti dal popolo ed i loro poteri hanno fondamento
nel popolo.
Gli auspici appartengono ad ogni cittadino
e conseguentemente al popolo, essendo questo la concreta somma di tutti i
cittadini. Dal popolo, gli auspici sono attribuiti ai magistrati attraverso la lex curiata (una particolare investitura
che avviene di fronte ai littori in rappresentanza del popolo riunito
nell’assemblea delle curie), fatta eccezione per i censori i cui auspici
hanno fondamento nei comizi centuriati[17].
Pertanto gli auspici dei magistrati, cioè il potere di consultare la
volontà divina nell’interesse della res publica, trovano fondamento negli auspici pubblici. Gli auspici dei magistrati sono pure
definiti pubblici, perché hanno come fondamento gli auspici del popolo;
il potere di consultare la divinità, quindi, non proviene al magistrato
direttamente dagli dèi.
La distinzione tra magistrati maggiori e
minori dipende dalla diversità degli auspici: coloro che hanno gli
auspici massimi sono definiti magistrati maggiori; coloro che hanno gli auspici
minori sono detti magistrati minori[18].
Tutti i magistrati, quindi, hanno auspici (il tribuno della plebe, che non
è un magistrato del popolo romano bensì della sola parte plebea,
non ha auspici); i magistrati maggiori hanno anche l’imperium (ad eccezione del censore), che consiste essenzialmente
nel potere di comandare un esercito e di riunire il popolo nei comizi.
Le più importanti attività
dei magistrati devono avvenire nei giorni fasti (secondo il calendario redatto dai
pontefici) e dopo che dallo stesso magistrato siano stati osservati segni
divini favorevoli (auspici); nonché in un luogo inaugurato nel quale sia
possibile la comunicazione con la divinità, perché le sostenga o,
più semplicemente, vi assista.
I comizi, di
regola, sono convocati dai magistrati maggiori (consoli e pretori) in un luogo inaugurato e solo dopo aver
accertato il favore degli dèi attraverso gli auspici. Il luogo
inaugurato è definito templum
ed è destinato allo svolgimento di attività magistratuali e
sacerdotali, in quanto da esso è possibile la comunicazione con la
divinità; l’augure è il solo sacerdote che possa procedere
alla inaugurazione dei luoghi. Gli auspici favorevoli, attraverso
l’interpretazione di determinati segni da parte dal magistrato che
convoca i comizi, attestano il sostegno della divinità.
Questo modello non può essere
modificato; il tentativo del tribuno della plebe Servilio Rullo nel 63 a.C. di
fare eleggere magistrati da comizi composti solo da diciassette delle trentacinque
tribù in cui è riunito il popolo romano, viene respinto e quei
comizi sono definiti “non veri”[19].
Il fondamento dei poteri magistratuali,
dunque, è nel popolo, inteso nella sua totalità, ovvero nella
concreta interezza delle sue parti, e l’elezione del magistrato non
è frutto di una imposizione divina, ma della volontà del popolo
sostenuta dalla divinità attraverso gli auspici favorevoli.
B) Sacerdoti
I sacerdoti sovrintendono ai culti della
città secondo varie specializzazioni. Quattro sono i collegi sacerdotali
più importanti a Roma: pontifices, augures, septemviri epulones,
decemviri sacris faciundis. I pontefici curano l’osservanza delle
norme rituali e la loro spiegazione al popolo; gli auguri sono gli interpreti
di Giove Ottimo Massimo attraverso i segni; gli epuloni organizzano banchetti
sacri in onore di Giove; i custodi ed interpreti dei Libri Sibillini si
occupano della conservazione e consultazione dei Libri Sibillini. Vi sono anche
numerosi sacerdoti non organizzati in collegi, come i flamini ed il re dei
sacrifici.
I sacerdoti organizzati in collegi sono
scelti dagli stessi membri del collegio nel quale entrano a far parte,
attraverso la cooptazione; gli altri sacerdoti sono scelti dal pontefice
massimo. Anche il pontefice massimo è scelto tra i pontefici dagli
stessi componenti del collegio pontificio.
Alla scelta del sacerdote, che in latino
è chiamata “creatio”,
deve fare seguito la inauguratio, una
particolare cerimonia attraverso la quale gli auguri pongono il nuovo sacerdote
in comunicazione con la divinità.
Tra i poteri dei sacerdoti sono gli
auspici; ma questi poteri hanno caratteristiche diverse da quelli
magistratuali, perché non hanno fondamento nel popolo che non partecipa
né alla scelta né alla inaugurazione dei sacerdoti. Gli auspici
sacerdotali, infatti, sono definiti privati, al pari di quelli dei singoli
cittadini, e se i sacerdoti sono chiamati pubblici ciò avviene in quanto essi appartengono, per dir
così, al popolo, ma non perché i loro poteri derivino dal popolo.
Pertanto, il fondamento dei poteri
sacerdotali non è nel popolo, ma è esclusivamente divino. La
distinzione tra i fondamenti dei poteri sacerdotali e dei poteri magistratuali
trova la sua ragione nella collocazione su piani distinti del potere del popolo
e del potere divino. I sacerdoti non hanno il potere di consultare la
divinità sulla base degli auspici del popolo; essi sono esperti dotati
di capacità e poteri religiosi che non hanno fondamento nel potere del popolo
ed il meccanismo della cooptazione e della scelta diretta del pontefice massimo
indica che la loro scelta non può e non deve dipendere dalla
volontà del popolo.
4. – L’introduzione del principio elettorale nella
scelta dei sacerdoti
Le modalità di scelta dei sacerdoti
cambiano a partire dal 212 a.C., anno in cui emerge nelle fonti
l’esistenza dei comitia pontificis
maximi, che provvedono alla elezione del pontefice massimo[20];
inoltre, nel 103 a.C. il tribuno
della plebe Domizio Enobarbo fa
approvare un plebiscito in virtù del quale la competenza sulla scelta di
sacerdoti organizzati in collegi (in particolare degli auguri, dei pontefici,
degli epuloni e dei custodi ed interpreti dei Libri Sibillini) è
attribuita ai comitia sacerdotiorum[21].
Con l’introduzione del principio elettorale nelle modalità di
scelta dei sacerdoti, la distinzione tra sacerdoti
e magistrati sembra meno netta.
Dall’esame delle fonti, però, è evidente che questa
distinzione non cade.
Un passo di Cicerone costituisce la migliore testimonianza su come erano strutturati
i comizi del pontefice massimo ed i comizi dei sacerdozi:
primum caput (...) legis agrariae (...) iubet
(...) tribunum plebis qui eam legem tulerit creare Xuiros per tribus XVII
(...). “ITEM,” inquit, “EODEMQVE MODO,” capite altero,
“VT COMITIIS PONTIFICIS MAXIMI.” Ne hoc quidem uidit, maiores
nostros tam fuisse popularis ut, quem per populum creari fas non erat propter
religionem sacrorum, in eo tamen propter amplitudinem sacerdoti uoluerint populo
supplicari. Atque hoc idem de ceteris sacerdotiis Cn. Domitius, tribunus
plebis, uir clarissimus, tulit, quod populus per religionem sacerdotia mandare
non poterat, ut minor pars populi uocaretur; ab ea parte qui esset factus, is a
conlegio cooptaretur[22].
Dal testo di Cicerone si ricava che: 1)
questi comizi sono organizzati per tribù e, pertanto, hanno la stessa
struttura dei comizi che eleggono i magistrati minori; 2) le tribù che
compongono tali comizi sono diciassette e, quindi, essi non hanno la stessa
composizione dei comizi tributi che eleggono i magistrati, che sono invece
formati da trentacinque tribù (cioè la totalità del
popolo); 3) queste diciassette tribù sono qualificate come “minor
pars populi”; 4) gli
eletti dai comizi sono successivamente cooptati dai rispettivi collegi.
A) La religione come limite ai poteri del popolo
Cicerone ricorre
alla frase: quod populus per religionem sacerdotia
mandare non poterat, per esprimere un concetto: le limitazioni al
potere del popolo[23].
E’ evidente che il ‘mandare
sacerdotia’ non rientra tra le attività che il popolo
può compiere. Vi sono infatti materie nelle quali il popolo non è dotato
di un potere dispositivo illimitato.
Per quanto
concerne le parole utilizzate dall’Arpinate per designare questa
‘carenza’, non v’è dubbio che ‘non poterat’ (da questo momento
adotterò l’espressione generica ‘non posse’), seguito da un verbo posto all’infinito,
sintetizza un tecnicismo[24].
L’aspetto interessante è però un altro; cioè il
fatto che nelle fonti ricorre molto raramente ‘populus non posse’.
In particolare, è evidente il silenzio delle fonti giuridiche,
ove questa espressione appare una sola volta[25],
per di più senza enunciare alcuna incompetenza a compiere atti,
limitandosi il giurista (si tratta di Giavoleno) ad evidenziare
l’inapplicabilità di alcune fattispecie proprie delle
servitù prediali al regime delle strade pubbliche[26]. Del resto, anche la formulazione
positiva (populus posse) è
pressoché inesistente nelle fonti giuridiche, utilizzata infatti solo da
Ulpiano per risolvere la famosa vicenda legata alla nomina, quale pretore, del servus fugitivus Barbarius Philippus[27].
Gioverà qui accennare
al fatto che più numerosi appaiono nelle fonti giuridiche i riferimenti
alla formulazione ‘non posse’
collegata ai municipes; si veda, ad esempio, Ulpiano in D. 4.3.15.1: sed
an in municipes de dolo detur actio, dubitatur. Et puto ex suo quidem dolo non
posse dari: quid enim municipes dolo facere possunt?
Da una ricerca
effettuata sulle fonti letterarie, anche con l’ausilio degli strumenti
informatici[28],
risultano quattro i casi in cui ricorre ‘populus non posse’, oltre a quelli contenuti
nell’orazione contro la rogatio
Servilia agraria; solo in una occasione, però, si può dire
che l’espressione indichi un difetto di appartenenza ed esercizio di
poteri. Si tratta di un noto passo di Cicerone sulla sanctio legis de
civitate Volaterranis adimenda, nell’orazione in difesa di Aulo
Cecina:
at
enim Sulla legem tulit... ascripsisse eundem Sullam in eadem lege: ‘SI
QUID IUS NON ESSET ROGARIER, EIUS EA LEGE NIHILUM ROGATUM’. Quid est quod ius non sit, quod populus iubere aut vetare non possit? Ut
ne longius abeam, declarat ista ascriptio esse aliquid; nam, nisi esset, hoc in
omnibus legibus non ascriberetur[29].
Nel brano,
l’Arpinate espone le ragioni del silenzio delle fonti, utilizzando la
forma interrogativa, retorica solo in apparenza; infatti, l’oratore
afferma che vi sono materie nelle quali il populus
non è dotato di un potere dispositivo illimitato[30]. Lo stesso Cicerone, in un’altra orazione, ritorna sul tema
della lex de civitate Volaterranis adimenda, sottolineando la carenza di
potere da parte del populus in
relazione alla sottrazione della cittadinanza romana agli abitanti di Volterra:
vero
Volaterranis, cum etiam tum essent in armis, L. Sulla victor re publica
reciperata comitiis centuriatis civitatem eripere non potuit... Hodieque
Volaterrani non modo cives, sed etiam optimi cives fruuntur nobiscum simul hac
civitate[31].
L’espressione
usata dall’Arpinate in quest’ultimo testo è simile a quella
usata nell’orazione per Cecina; pur mutando il soggetto grammaticale, il
soggetto logico è lo stesso: il populus
nella organizzazione comiziale (Sulla
comitiis centuriatis non potuit – populus non possit). Pertanto, nei due testi di Cicerone
è evidente che la potestas populi
non è illimitata, tanto che l’oratore ricorda che nella lex Cornelia de civitate Volaterranis
adimenda era contenuta un’apposita sanctio legis dal contenuto generale (SI QUID IUS NON ESSET ROGARIER,
EIUS EA LEGE NIHILUM ROGATUM).
Le affermazioni di Cicerone non si
scontrano con l’enunciato della norma delle XII Tavole relativa al potere
legislativo del popolo (in XII tabulis
legem esse, ut quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset:
Liv. 7.17.12), perché il precetto decemvirale, stabilendo certamente che
gli iussa populi creano iura, pone la parola ‘postremum’ a qualificare e
limitare l’oggetto ‘quodcumque’[32];
la norma delle XII Tavole non dispone dunque che il popolo possa creare diritto
oltre ogni limite fissato da altre fonti dello ius[33].
Nel testo
dell’orazione contro la proposta legislativa di Servilio Rullo (...
quod populus per religionem sacerdotia mandare non poterat), è
evidenziata con terminologia analoga una carenza di potere da parte del popolo
con riguardo ad una fattispecie concreta, la cui specificità realizza
una di quelle ipotesi genericamente delineate da Cicerone nella precedente
orazione in difesa di Aulo Cecina con l’ausilio di pronomi neutri (quid ... quod ... aliquid)[34].
Il fatto che
l’espressione ‘populus non
posse’ non appaia nelle fonti prima di Cicerone e che lo stesso
Arpinate la utilizzi per teorizzare limitazioni ai poteri del populus, dimostra la presenza di una
più acuta sensibilità, nell’ultimo secolo della repubblica,
per la puntualizzazione della vicenda sotto il profilo politico e dogmatico;
sensibilità dovuta probabilmente alla necessità di ribadire
concetti non più condivisi con uguale intensità.
Nelle nuove modalità di scelta dei
sacerdoti appare evidente il riconoscimento della distinzione tra
volontà divina e volontà umana, tra diritto sacro e
“sovranità” popolare, sotto il duplice profilo del
fondamento dei poteri sacerdotali e della espressione del potere del popolo: il
popolo non può attribuire ciò che non possiede, e questo
perché verrebbe concretamente stravolto il sistema stesso di poteri sui
quali il popolo medesimo si fonda.
Secondo la
ricostruzione di Cicerone, pertanto, la scelta dei sacerdoti organizzati in
collegi non può essere effettuata attraverso gli strumenti con i quali
il popolo usa ‘conferire le magistrature’;
l’attività svolta dall’universus populus nella elezione
dei magistrati produce effetti giuridici non adattabili alla scelta dei sacerdoti.
B) Minor pars populi
Se il popolo non
può ‘conferire i sacerdozi’ come invece può
‘conferire le magistrature’, è allora necessario che
l’elezione comiziale dei sacerdoti produca effetti diversi da quelli
cagionati seguendo le procedure previste per le magistrature. Ecco allora il
meccanismo individuato da Domizio: non è il ‘popolo intero’
organizzato nei comizi delle trentacinque tribù che elegge i sacerdoti,
ma sono alcune ‘parti
del popolo’, le diciassette tribù, che scelgono il nome del candidato da cooptare.
Il rapporto
‘somma-popolo’ e ‘addendi-parti’, presente nel
concetto di ‘minor pars
populi’ espresso da Cicerone[35],
è puntualizzato dai giuristi: Servio Sulpicio Rufo[36]
ed il suo allievo Alfeno Varo[37],
Ateio Capitone[38]
ed il suo allievo Masurio Sabino[39]
si interrogano sulla funzione che le parti del popolo possono svolgere sul
piano costituzionale. Parimenti, la definizione di ‘parte’
elaborata dal giurista Quinto Mucio Scevola[40]
è stata ispirata anche dalla necessità di mettere a fuoco
concetti quali ‘parte-parti del popolo’: la ‘minor
pars’ non può
realizzare quegli effetti giuridici che solo ‘omnes partes’ o
‘maior pars’ possono produrre[41].
La ‘minor
pars populi’ permette di risolvere il problema della carenza di
potere del popolo nella scelta dei sacerdoti. Le modalità di scelta dei magistrati non sono in alcun modo applicabili alla scelta dei
sacerdoti; e questo, non solo perché la relazione tra cittadini elettori
e magistrati eletti si fonda su principi quali ‘omnes potestates ab universo populo
proficisci convenit’[42],
ma anche perché non è l’elezione comiziale, da sola, che
costituisce la scelta del sacerdote.
5. – La cooptazione
Dal passo di Cicerone
si ricava che la cooptazione resta comunque un atto necessario ai fini della
scelta del sacerdote, pur dopo l’introduzione del principio elettorale[43].
La procedura di creatio dei sacerdoti
organizzati in collegi si fonda, pertanto, su due elementi, uno nuovo e
l’altro, precisamente la cooptatio, preesistente al plebiscito
rogato da Domizio:
a)
la scelta del sacerdote è rimessa a comitia
che non comprendono l’universus populus, ma solo la minor
pars (ab ea parte qui esset factus);
b)
la cooptatio resta comunque atto necessario
ai fini della creatio del sacerdote (is a conlegio cooptaretur).
La
cooptazione, a fronte dell’introduzione della novità costituita
dalla preliminare elezione comiziale del candidato al collegio sacerdotale,
assume una valenza formale per ciò che concerne la scelta
dell’aspirante alla carica, ma conserva tutto il suo valore sostanziale
in relazione ai presupposti necessari ai fini della creatio e, dunque,
della inauguratio del sacerdote[44].
Quindi,
la vicenda può essere analizzata da due prospettive diverse. Sotto il profilo dei poteri dei collegi
sacerdotali, è palese il loro decadimento, seppur parziale: la scelta
del nome del futuro sacerdote è sottratta ai membri dei collegi per
essere attribuita ai comitia composti da diciassette tribù,
estratte a sorte fra le trentacinque in cui è suddiviso il populus
Romanus. Nella prospettiva della cooptatio,
intesa come presupposto necessario ai fini della creatio e, quindi,
della inauguratio del sacerdote, è invece evidente la sua
perfetta tenuta: questo atto mantiene la sua essenzialità, dimostrando
di non essere sopprimibile né sostituibile.
In
altri termini, il ruolo dei comitia sacerdotum trova il suo limite nella
stessa cooptatio, come i poteri dei comitia tributa elettorali
sono definiti dalle funzioni del magistrato presidente. Nell’anno del plebiscito rogato
da Domizio, cioè in un tempo in cui i rapporti
tra i comitia ed i magistrati che li presiedono sembrano tendere verso una
maggiore autonomia dei primi, il sistema elettorale, pur basato sulla minor
pars populi, è esteso alla scelta dei nominativi dei futuri
sacerdoti, ma è fermato di fronte alla valenza funzionale della
cooptazione.
Sulla
base di quel poco che è possibile ricavare dalle fonti epigrafiche, mi
sembra sia attestata una sorta di ‘supremazia’ della cooptatio
sulla elezione dei comitia sacerdotum; infatti, il modo di citare
l’assunzione di nuovi membri all’interno dei collegi sacerdotali
non muta neppure dopo l’emanazione del plebiscitum rogato da
Domizio, apparendo menzionata esclusivamente la cooptazione[45].
La cooptatio,
pertanto, costituisce un atto imprescindibile nel procedimento che conduce al
sacerdozio. Senza di essa
l’eletto dai comitia non può in alcun modo accedere alla inauguratio,
come sembra dimostrare Cicerone in un celebre passo del Brutus[46]. Elezione e cooptazione, procedendo da
strade del tutto diverse, convergono in una sorta di atto complesso, ove la
concorrenza di entrambe fa sì che esso possa produrre i suoi effetti.
Il ruolo dei
comizi del pontefice massimo e dei sacerdozi trova, quindi, il suo limite nella
stessa cooptazione. Al momento dell’elezione, il candidato al pontificato massimo è
già sacerdote, cooptato
all’interno del collegio dei
pontefici e successivamente inaugurato
come pontefice. Allo stesso modo, chi viene eletto dai comizi dei sacerdozi non per questo entra a far parte dei collegi sacerdotali, perché
solo la cooptazione da parte di
questi ultimi perfeziona il procedimento della scelta del sacerdote.
L’imprescindibile
valore giuridico della cooptazione appare ancor più chiaro alla luce
delle particolari regole che disciplinano il funzionamento di questi comizi e
le candidature. Il fatto che queste ultime siano gestite esclusivamente
all’interno del collegio, attraverso il meccanismo della nominatio da parte dei
membri del collegio stesso[47],
unitamente alle limitazioni circa il numero dei candidati presentabili[48],
dimostra che i comizi sono chiamati sì ad operare una scelta, ma nei
ristretti ambiti disegnati dai collegi sacerdotali.
6. – La partizione
del diritto pubblico romano, dalla repubblica all’età imperiale
fino a Giustiniano
L’esame delle caratteristiche dei
comizi del pontefice massimo e dei successivi comizi dei sacerdozi costituisce
un percorso obbligato per chi voglia approfondire la relazione tra religione e
diritto. Nel momento in cui è coinvolto il popolo nella scelta dei
sacerdoti, si avverte la necessità di puntualizzare tre aspetti:
a)
il
popolo, nella sua interezza, non può “nominare” sacerdoti o
“conferire” sacerdozi perché violerebbe i principi
giuridico-religiosi sui quali si basano i suoi stessi poteri;
b) gli effetti prodotti dagli atti posti in
essere dall’intero popolo sono diversi da quelli prodotti da sue parti;
c) il fondamento dei poteri sacerdotali
è e rimane esclusivamente divino.
Da ciò
emerge che l’introduzione del principio elettorale nella scelta dei
sacerdoti non muta i principi sui quali si basa il sistema giuridico-religioso romano:
i fondamenti dei poteri dei sacerdoti sono distinti da quelli dei magistrati,
come distinti sono i piani su cui si trovano il potere divino e il potere del
popolo, che però non sono separati né isolati.
Nel popolo, quindi, sono i fondamenti dei
poteri magistratuali, ma essi non sono separati né isolati dalla
volontà divina. Giove è indicato come re degli dèi e degli
uomini e tutti i poteri, anche quelli umani, si ritiene che abbiano origine nel
potere divino[49].
Tuttavia, il potere del popolo e il potere della divinità non sono posti
sullo stesso piano, ma su piani distinti. Giove è qualificato come
onnipotente, ma la divinità non impone la propria volontà alla
volontà del popolo, piuttosto ne sostiene la estrinsecazione attraverso
gli auspici. La stessa localizzazione del popolo romano e l’inizio della
sua organizzazione giuridica sono sostenute ed autorizzate dalla
divinità.
In questo sta il
carattere popolare della religione nella repubblica romana. Il popolo entra nei
meccanismi di scelta di sacerdoti e magistrati: nel caso dei magistrati, in
modo pieno e sostenuto dalla volontà divinità attraverso gli
auspici; nel caso dei sacerdoti, in modo parziale ed estraneo al fondamento
divino dei loro poteri. E questo modello permarrà anche
nell’età imperiale. In un testo del giurista Ulpiano, infatti,
è teorizzata la
partizione del diritto pubblico, in base alla quale sacerdoti e magistrati sono
parti (distinte) dello stesso sistema giuridico:
publicum
ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit[50].
Ed
i compilatori giustinianei recepirono questa partizione tra i principi del
Titolo I del primo Libro del Digesto.
Da qui, ancora, l'idea di ‘consonantia’ (o, in greco,
di ‘symphonia’) tra sacerdotium et imperium, espressa dallo stesso
Giustiniano nel 535 nella Nov. 6 [51].