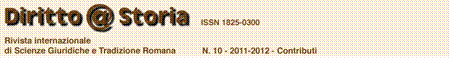Specialità
e asimmetria nel sistema regionale italiano*
Università
di Sassari
SOMMARIO: 1. Due idealtipi – 2. Il
modello cooperativo – 3. Il modello asimmetrico – 4. I
due idealtipi nel regionalismo italiano – 5. L’autonomia statutaria e
legislativa – 6. La
matrice comune alle diverse specialità finanziarie – 7. Ruolo
e rendimento delle norme di attuazione
degli statuti speciali – 8. La specialità finanziaria
“forte” e “debole”
– 9. Conclusione. – Abstract.
1. – Due idealtipi
I sistemi federali e regionali
possono essere distinti e classificati secondo diversi criteri e modelli. In
questa mia relazione, che ha per oggetto la specialità e
l’asimmetria nel regionalismo italiano, vorrei occuparmi in particolare
di due idealtipi tra loro speculari: il federalismo/regionalismo cooperativo, integrativo e simmetrico
e quello asimmetrico, differenziato e competitivo. Il confronto tra questi due modelli, o idealtipi,
può essere di una qualche utilità per inquadrare il tema
affidatomi. Inizio dal modello più risalente, cioè da quello
cooperativo, integrativo e simmetrico.
2. – Il modello cooperativo
Com’è noto, il federalismo cooperativo nasce negli Stati Uniti d’America sulle ceneri
del vecchio federalismo duale[1].
La sua affermazione è legata allo sviluppo del welfare state impresso dal New
Deal roosveltiano. Dai primi anni ’30 del secolo scorso
l’interventismo crescente dei poteri federali in materia sociale ed
economica, con la moltiplicazione dei compiti pubblici nelle politiche del
lavoro, dei redditi, dell’istruzione, della previdenza,
dell’assistenza sanitaria, ecc., trasforma profondamente il vecchio stato
liberale in un administrative state.
Il governo del welfare si centralizza
e, attraverso lo strumento fiscale, persegue l’obiettivo di redistribuire
la ricchezza in modo da garantire a tutti i cittadini un livello minimo di
benessere e migliori opportunità di vita.
Il passaggio dallo stato liberale allo stato sociale non è
privo di ripercussioni sulla struttura federale. Si espandono progressivamente
le competenze federali e diventa recessiva l’idea, tipica del federalismo
duale, di una rigida ripartizione di competenza tra federazione e stati membri.
L’accentramento a livello federale è, però, compensato dal
rafforzamento dei meccanismi e dei raccordi cooperativi tra centro e periferia:
se cresce il potere degli organi federali, deve conseguentemente crescere
l’influenza di ciascuna entità federata sui processi decisionali
accentrati. Per un verso ciascuno stato membro subisce una contrazione delle
sue competenze esclusive, dei suoi spazi di autodeterminazione singolare; per
l’altro cresce – proporzionalmente – il suo potere di
contribuire alla formazione della volontà federale, ossia
all’autodeterminazione collettiva.
In sintesi, la logica di fondo del federalismo cooperativo
consiste nel ridurre l’autonomia negativa
di ciascuna entità federata a vantaggio di quella positiva: sicché si limitano le loro funzioni esclusive e si
valorizzano, invece, quelle che si esercitano in forma integrata nelle sedi di
codecisione federale[2].
Si riduce quindi il numero delle decisioni che ciascuna entità federata
può assumere singolarmente e in
modo differenziato e cresce, di contro, il numero di quelle che debbono
prendersi di comune accordo. Il modello cooperativo è, dunque, integrativo in due sensi: perché
è funzionale a un sistema di welfare
che realizza la coesione, l’integrazione sociale; e perché si
regge sulla forte integrazione istituzionale e decisionale dei livelli di
governo.
Inoltre il modello cooperativo è anche simmetrico. L’intero prevale sulla
parte ma tutte le singole parti concorrono a
eguale titolo e con eguali poteri alle decisioni dell’intero. La
federazione si relaziona allo stesso modo con ciascuna parte o entità
federata: nel federalismo cooperativo il sistema delle relazioni
interordinamentali è essenzialmente multilaterale e paritario –
ferma restando la tendenziale preminenza dell’intero, ossia degli organi
federali – e raramente di tipo bilaterale e asimmetrico, ossia in modo da
privilegiare o differenziare alcuni stati membri nel rapporto col centro[3].
Infine, va detto che il modello federale cooperativo dello stato
sociale è al servizio di una logica
individualistica (ma forse sarebbe più corretto dire personalistica). Difatti, questa
complessa architettura cooperativa, integrata e simmetrica si accompagna a un
modello redistributivo centralizzato, per il quale rilevano le esigenze
individuali di welfare e i cleavages sociali e non le differenze
territoriali: i destinatari delle prestazioni assistenziali e i beneficiari
degli interventi redistributivi sono i singoli individui o famiglie o gruppi
sociali svantaggiati – quale che sia la loro collocazione geografica nel
territorio della federazione – e non le comunità territoriali.
Tutti i poveri hanno gli stessi diritti e tutti i ricchi hanno gli stessi
doveri, senza che assuma rilievo la loro appartenenza a comunità
territoriali floride o depresse[4].
3. – Il modello asimmetrico
Finora ho illustrato le caratteristiche del federalismo
cooperativo guardando soprattutto all’esperienza statunitense. Ma non
c’è alcun dubbio che pure il sistema tedesco sia stato –
perlomeno fino a qualche tempo fa – un esempio perfetto, quasi
paradigmatico, di assetto federale cooperativo, integrato e simmetrico.
Sennonché dagli anni ’90 il modello cooperativo
germanico è divenuto oggetto di contestazione. Furono tre, in
particolare, i fattori di crisi: a) la
paralisi decisionale determinata dai veti incrociati: uno sbocco probabile in
un sistema di competenze integrate, intrecciate, il cui esercizio avviene nelle
sedi di codecisione[5];
b) l’appannamento del principio
di responsabilità politica, visto l’intreccio complesso delle
competenze dei diversi livelli di governo e la conseguente difficoltà di
distinguere con precisione le responsabilità di ciascuno
nell’attuazione o inattuazione delle politiche pubbliche; c) le rivendicazioni avanzate dai Laender più sviluppati
economicamente, anche per reazioni ai due fattori di crisi precedentemente
indicati.
Alla luce di queste motivazioni nel 1994 e nel 2006 furono
introdotti degli elementi di federalismo asimmetrico e competitivo[6].
Ma cosa s’intende con questa formula?
Per certi versi il federalismo asimmetrico/competitivo esprime un
movimento inverso rispetto a quello cooperativo, simmetrico e integrativo. Il
suo principio animatore è la pretesa delle comunità territoriali
di “poter fare da sole”, attraverso la rivendicazione di spazi
crescenti di autodeterminazione singolare, ossia di più ampie e numerose
competenze esclusive. Ora, è evidente che se crescono le competenze
esclusive, si riduce inevitabilmente l’incidenza di quelle integrate, esercitabili
nelle sedi di co-decisione federale. Prevale dunque la spinta a valorizzare
l’autonomia negativa su quella positiva, con un trade-off rovesciato rispetto a quello che caratterizza il modello
cooperativo.
Tutto ciò non può essere privo di conseguenze
riguardo all’organizzazione dello stato sociale. Per effetto di un
rafforzamento progressivo dell’asimmetria competenziale, è nella
logica delle cose che il livello federale sia costretto a dismettere alcuni
settori del governo centralizzato del welfare,
con la riallocazione dei relativi compiti a livello locale, secondo una logica
di differenziazione territoriale dei servizi sociali e delle prestazioni
assistenziali. In un quadro siffatto la federazione conserverebbe solo il
compito di assicurare il rispetto dei «livelli essenziali» delle
prestazioni di welfare[7]
e dalla garanzia federale delle condizioni «uniformi» di vita si
passerebbe alla, sicuramente meno intensa, garanzia di condizioni
«equivalenti»[8].
La clausola dei «livelli essenziali» è,
dunque, un istituto del federalismo asimmetrico-competitivo e non di quello
cooperativo-welfaristico, nonostante possa sembrare il contrario. Finora non si
è riflettuto abbastanza su quanto sia problematico il nesso tra la
formula costituzionale dei «livelli essenziali» e il principio di
eguaglianza di cui all’art. 3, comma 2, della Costituzione.
L’eguaglianza sostanziale esprime una direzione obbligata: la rimozione
degli ostacoli di ordine economico-sociale che impediscono il pieno sviluppo
della persona e la partecipazione effettiva all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese. Questo «pieno sviluppo» e
«partecipazione effettiva» esigono l’avanzamento progressivo
delle dinamiche redistributive e non sono istanze che possono essere soddisfatte
dalla sola garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. I «livelli
essenziali» non esprimono una direzione obbligata: se c’è
infatti una competenza nazionale sui livelli essenziali, la regione è
competente circa la scelta se tenere inalterato il livello previsto dallo Stato
o se innalzarlo.
Insomma, nella logica del modello asimmetrico la garanzia
federale, centralizzata, dei diritti sociali deve mantenersi a un livello
minimo, onde lasciare ai poteri locali la discrezionalità di
determinarne livelli ulteriori: se è vero che la concezione
“espansiva” dello stato sociale esige l’espansione dei poteri
federali e l’accentramento dei poteri d’intervento pubblico
(seppure nel quadro di modalità integrate d’esercizio), allora
è inevitabile che la contrazione dei poteri centralizzati – a
vantaggio di una maggiore differenziazione delle competenze locali –
s’accompagni con una concezione minimale del welfare federale.
Ovviamente nel modello asimmetrico e competitivo non scompaiano
le istanze costituzionali della solidarietà economica e sociale.
Tuttavia perde forza propulsiva il modello redistributivo centralizzato secondo
cui i portatori di bisogni sarebbero gli individui e i gruppi sociali: a questo
modello si sostituisce gradualmente il metodo della perequazione territoriale
delle risorse finanziarie, secondo cui i destinatari diretti
dell’intervento solidaristico-redistributivo non sarebbero più gli
individui e i gruppi sociali svantaggiati – quale che sia la loro
appartenenza territoriale – ma le comunità territoriali con minore
capacità fiscale. Soggetti di diritti e di doveri non sono più
gli individui ma i territori.
Non è un caso che la spinta verso il federalismo (o
regionalismo) asimmetrico provenga dalle comunità territoriali
più forti economicamente, alle quali conviene adottare il nuovo modello
della perequazione territoriale anziché quello redistributivo
tradizionale, non fosse altro perché cresce la quota del reddito che
viene trattenuto in loco
anziché messo a disposizione della redistribuzione centralizzata[9].
Infine, va detto che la perdita della simmetria
nell’assetto delle competenze – perché qualcuno acquista
più competenze di altri – muta altresì il rapporto tra
centro e periferia, tra l’intero e le sue parti costitutive: alcune
parti, alcuni lembi di periferia, pretendono di relazionarsi direttamente col
centro, con l’intero, in forma singolare e non più collettiva;
ossia – forti del peso economico-finanziario e dell’influenza
politica acquisita – non si confrontano più col centro nelle sedi
comuni e multilaterali di raccordo e codecisione, ma preferiscono curare i loro
interessi attraverso una negoziazione bilaterale con il governo centrale.
4. – I due idealtipi nel regionalismo italiano
Come già si è detto, i due modelli descritti sono
degli idealtipi. Nelle esperienze costituzionali effettivamente esistenti
ritroviamo sempre, in misura più o meno significativa, una commistione
di entrambi. Ad esempio, il sistema federale tedesco è ancora
essenzialmente di tipo cooperativo, sebbene le riforme del 1994 e del 2006
abbiano iniettato dosi sensibili di federalismo asimmetrico e competitivo, con
un trade-off tra cooperazione e
competizione.
Anche il regionalismo italiano realizza una peculiare commistione
di entrambi i tipi. La costituzionalizzazione del principio di leale
collaborazione, gli strumenti di raccordo cooperativo che si compendiano nel
sistema delle conferenze, la tendenza a leggere in modo flessibile e integrato
i riparti competenziali, sono indubbiamente elementi che richiamano il modello
cooperativo. Invece sono da ricondurre all’altro modello la
possibilità per le Regioni di ottenere una differenziazione delle
competenze legislative, secondo quanto previsto dall’art. 116, comma 3,
Cost.[10],
e le linee guida del processo attuativo del federalismo fiscale contenute nella
legge n. 42 del 2009 e nei relativi decreti[11].
Anche l’esperienza delle cinque regioni speciali
costituisce inveramento del modello asimmetrico-competitivo? La risposta
è complessa e conviene avvicinarvisi per gradi. Prenderò in esame
tre profili differenti: l’autonomia statutaria, l’autonomia
legislativa e, infine, l’autonomia finanziaria.
5. – L’autonomia statutaria e legislativa
Inizio con l’autonomia statutaria. È ovviamente
opportuno distinguere i due versanti dello statuto propriamente detto e della
legge statutaria.
Per quanto riguarda il primo versante, a prima vista parrebbe
scontato richiamare il modello asimmetrico, almeno per due ragioni. In primo
luogo perché la forma costituzionale dello statuto differenzia la regione speciale da quella ordinaria, creando una
forma di asimmetria tra le due tipologie di regione. In secondo luogo
perché lo statuto speciale è una legge costituzionale sui generis, atipica, con ciò
confermando e approfondendo la peculiarità delle esperienze regionali
speciali, anche nel quadro della sistematica generale delle fonti
(costituzionali)[12].
Tuttavia, nonostante questi elementi d’indubbia asimmetria,
è difficile sostenere che in questo caso ci troviamo dinanzi a un
inveramento genuino del modello asimmetrico-competitivo (inteso nel senso
ricostruito nelle pagine precedenti). La legge costituzionale atipica che
modifica lo statuto speciale è pur sempre un atto di competenza del
Parlamento nazionale e non degli organi regionali. Certo, è vero che la
formazione della legge di revisione statutaria è arricchita da un onere
sconosciuto alla legge costituzionale tipica: la richiesta del parere del
Consiglio della regione interessata. Ed è anche vero che il corpo
elettorale nazionale non può, tramite referendum, mettere in discussione
la modifica statutaria approvata con la partecipazione consultiva regionale.
Sennonché si tratta di una fase partecipativa molto
“debole”, che non intacca in modo sostanziale il potere decisionale
del Parlamento (e che peraltro non compensa la perdita della fase
referendaria). Sicché la forma costituzionale dello statuto speciale non
solo non è espressione di maggiore autonomia (negativa o positiva)
rispetto a quanto goduto dalle regioni ordinarie, ma non è neppure
espressione di autonomia tout court.
Non è, infatti, un atto di autonomia.
Per quanto riguarda il versante della legge statutaria, la
conclusione non è diversa: la potestà di adottarne una è
sicuramente una forma di minore autonomia rispetto alla potestà
statutaria riconosciuta alle regioni ordinarie. Per avvedersene, basta
raffrontare gli elenchi degli oggetti ricadenti nella competenza dell’una
e dell’altra: diversamente dagli statuti ordinari, infatti, le leggi
statutarie di regione speciale non sono competenti in materia di
«principi di organizzazione e funzionamento», con quel che ne
consegue circa la possibilità per la regione speciale di disciplinare il
proprio procedimento legislativo[13].
Vengo all’autonomia legislativa. Sotto questo profilo, se
guardiamo alla prassi avallata dalla giurisprudenza costituzionale, non esiste
una vera differenziazione tra regioni ordinarie e speciali. Nel tempo abbiamo
assistito a uno smussamento progressivo delle differenze tra le competenze
legislative delle due tipologie di regione: quello che lo Stato può fare
nei confronti delle funzioni legislative delle regioni ordinarie lo può
fare anche nei confronti delle funzioni legislative delle regioni speciali,
sicché il sistema complessivo dei limiti statali alle competenze
regionali è sostanzialmente il medesimo per le regioni ordinarie e
speciali[14].
E dunque, quale bilancio se ne deve trarre? Che
l’esperienza delle regioni speciali ha poco o nulla a che vedere col
modello asimmetrico-competitivo, perché o l’asimmetria a conti
fatti non c’è oppure se c’è non è certo
strumentale alla costruzione di un’autonomia più competitiva?
6. – La matrice comune alle diverse specialità
finanziarie
La risposta affermativa alla domanda che chiude il paragrafo
precedente sarebbe una conclusione affrettata. Bisogna, infatti, focalizzare
l’attenzione su un altro aspetto: ora l’essenza della
specialità è soprattutto la differenziazione del regime
finanziario. Per come si è evoluta l’esperienza delle regioni
speciali, il proprium della
specialità, il suo attuale significato, riguarda ormai soprattutto il
versante delle relazioni finanziarie con lo Stato. È, dunque, una specialità finanziaria, prima
ancora che una specialità del riparto delle competenze legislative e
amministrative.
Ciò premesso, occorre chiedersi se la specialità
finanziaria sia una categoria omogenea oppure se, per via della grande
varietà delle soluzioni e degli istituti adottati nelle discipline
statutarie, le diverse esperienze regionali speciali siano irriducibili a un
modello unitario che funga da comune denominatore. Recentemente
c’è chi ha correttamente sostenuto che esiste, sul punto, una
«matrice comune» alle diverse esperienze speciali, riassumibile nei
seguenti elementi[15]:
a) a parte i tributi propri, variamente identificati e
identificabili, le entrate regionali dipendono soprattutto dalla
«devoluzione dei gettiti locali delle imposte statali», cioè
da compartecipazioni al gettito erariale riferibile al territorio;
b) il livello di questa devoluzione o compartecipazione è
direttamente proporzionale al livello della spesa affidata alla regione
speciale, cioè «è tanto più significativa, sia in
termini di quota del gettito che di tributi interessati, quanto maggiori sono
le competenze di spesa»;
c) in base agli statuti «non sono previste forme di
perequazione se non per colmare deficit infrastrutturali» (ma ciò
solo limitatamente a favore di talune regioni speciali: mi riferisco al Fondo
di solidarietà per la Sicilia ex art. 38 Stat. Siciliano, al Piano di
Rinascita per la Sardegna ex art. 13 Stat. Sardo);
d) e specularmente, «non è prevista la
partecipazione delle autonomie speciali a forme di solidarietà
nazionale, se non attraverso la parte non devoluta dei tributi erariali
localmente riscossi»[16].
A questo elenco aggiungerei, infine, quest’ultimo punto: e)
la manutenzione, l’aggiornamento, la correzione dell’assetto
finanziario della regione speciale si realizzano attraverso il metodo della
negoziazione bilaterale con lo Stato, e quindi per mezzo di quelle peculiari
fonti chiamate «norme di attuazione degli statuti speciali» (su cui
ritornerò tra breve).
Come si vede, la logica sottesa alla specialità
finanziaria non è certo quella del modello cooperativo (integrativo e
simmetrico): ci troviamo, infatti, di fronte a un’applicazione
particolarmente intensa del modello asimmetrico-competitivo, il cui principio
animatore è – come si è detto – la pretesa delle
comunità territoriali di “poter fare da sole” attraverso la
rivendicazione di maggiori spazi di autodeterminazione esclusiva. In
particolare, in questo caso ci troviamo di fronte a un “principio di
territorialità”, così formulabile: il gettito fiscale prodotto da un territorio, da una comunità
territoriale, deve tendenzialmente rimanere e, quindi, essere speso nel
territorio di provenienza.
È evidente che questo principio istituisce «un
rapporto stretto tra risorse regionali ed economia locale», determinando
«una forma di estrema responsabilizzazione dell’ente rispetto ai
propri destini finanziari»[17].
In coerenza con questa logica “territoriale” non c’è,
conseguentemente, una partecipazione a meccanismi di solidarietà nei
confronti del resto del Paese: «se l’economia locale si sviluppa,
il “dividendo fiscale” va a vantaggio della comunità locale;
se l’economia peggiora, è la stessa comunità a sopportare
in via esclusiva le conseguenze»[18].
7. – Ruolo e rendimento delle norme di attuazione degli statuti speciali
Tuttavia all’interno di questa matrice comune della
specialità finanziaria, espressiva di una logica omogenea, si possono
registrare oscillazioni e differenziazioni anche molto pronunciate.
I fattori che ne sono all’origine sono diversi, ma un ruolo
preponderante va sicuramente riconosciuto alle norme di attuazione degli statuti speciali. Si tratta di una
tipologia di fonti che evidentemente rappresenta un inveramento del modello
asimmetrico, poiché evoca la concezione della specialità come
“rapporto singolare con lo Stato”, come relazione bilaterale col
Governo nazionale.
Ebbene, finora le norme di attuazione sono state adoperate
soprattutto per dosare il livello delle devoluzioni, delle compartecipazioni ai
gettiti erariali riferibili al territorio e, contestualmente, per trasferire
competenze di spesa: per loro tramite si è realizzato un costante scambio
tra innalzamento delle compartecipazioni (o interpretazione/applicazione
estensiva dei criteri di compartecipazione) e oneri aggiuntivi legati alla
regionalizzazione di funzioni originariamente statali.
Tuttavia il rendimento di questo strumento non è uguale
per tutte le regioni speciali. Guardiamo i dati. Finora sono stati emanati
circa 500 decreti di attuazione degli statuti speciali; oltre un terzo negli
ultimi quindici anni. Il dato eloquente è la loro distribuzione regione
per regione. Sono così ripartiti: Trentino-Alto Adige 38, Valle
d’Aosta 16 (dato aggiornato al 2010), Friuli-Venezia Giulia 15 (dato
aggiornato al 2010), Sicilia 7 (al 2010), Sardegna 6 (al 2010). Lo scarto tra
le regioni speciali settentrionali e quelle insulari, con la Sardegna come
fanalino di coda, non potrebbe essere più evidente.
Ciò dimostra, inoltre, che
non è vero – come spesso si afferma – che le norme di
attuazione siano di per sé un ostacolo allo sviluppo autonomistico[19].
Invero, possono essere indifferentemente una risorsa ovvero un freno al
potenziamento delle prerogative regionali speciali, secondo la capacità
delle classi dirigenti locali di interloquire in modo fruttuoso col Governo.
L’esito delle relazioni bilaterali tra la singola regione speciale e l’esecutivo
nazionale dipende fortemente dalla capacità di ciascuna Regione di
individuare e rappresentare con efficacia le proprie esigenze, e dal
“potere contrattuale” di ognuna di esse[20].
Tuttavia – come evidenziato anche dal dato quantitativo di
cui sopra – il bilancio è decisamente negativo per le
specialità insulari. C’è come una sorta di
marginalità insulare rispetto al movimento regionale complessivo, con
gravi ritardi istituzionali e culturali. Ciò è emerso soprattutto
in occasione dei grandi trasferimenti di funzioni operati dallo Stato a favore
delle autonomie territoriali. In tali circostanze anche la Sicilia e la
Sardegna, come del resto le altre speciali, si sono trovate a dover
“inseguire” le regioni ordinarie. Ma l’adeguamento del
corredo di funzioni a quello posseduto dalle regioni ordinarie, almeno nel caso
dei trasferimenti di funzioni del 1972 e del 1977, non è stato per nulla
solerte, né efficiente.
Insomma, è senz’altro possibile affermare che, lo
strumento delle norme di attuazione non sia riuscito a potenziare
l’autonomia speciale insulare come forse ci si sarebbe potuti aspettare.
Non ha certo rappresentato quella corsia preferenziale che invece è
stato in altre esperienze. Anzi, per più di un verso, e in molteplici
occasioni, ha rappresentato un ostacolo allo sviluppo dell’autonomia
regionale.
8. – La specialità finanziaria “forte” e
“debole”
Grazie agli sviluppi
illustrati le regioni speciali del Settentrione hanno realizzato una
specialità finanziaria “forte”; una specialità,
quindi, che è un’applicazione particolarmente intensa del
“principio di territorialità”. La comunità
territoriale trattiene la quasi totalità del proprio gettito, facendosi
carico in cambio della quasi totalità delle funzioni pubbliche potenzialmente
esercitabili sul territorio, finanche di quelle originariamente e
tradizionalmente spettanti allo Stato; realizza, quindi una condizione di
autosufficienza finanziaria e tendenzialmente potrebbe sopportare
l’intero onere della spesa pubblica; l’esempio più eloquente
sono le funzioni e le spese in materia di istruzione, finanza locale e
previdenza (oltre, ovviamente, alla sanità). E ciò è stato
possibile non solo per il particolare attivismo delle loro classi dirigenti, ma
anche e soprattutto perché sono comunità territoriali con
un’elevata capacità fiscale per abitante. Insomma, sono territori
competitivi e, coerentemente, pretendono forme particolarmente accentuate di
federalismo differenziato e asimmetrico.
Per quanto riguarda invece le regioni speciali insulari (Sicilia
e Sardegna), non si può certo dire che abbiano inverato un modello
“forte” di specialità finanziaria: le norme di attuazione
sono state scarse e quelle poche non hanno certo realizzato quello scambio di
cui parlavo prima, tra innalzamento delle devoluzioni finanziarie e assunzione
di funzioni aggiuntive con relativi oneri di spesa.
Ciò detto, è evidente che le regioni speciali del
Settentrione hanno sicuramente interesse a mantenere una condizione di
specialità finanziaria “forte”. Non c’è alcun
dubbio che, in ossequio a questa logica di territorializzazione
dell’assetto finanziario, alle regioni speciali del Settentrione conviene
conservare il loro attuale regime, perché con le risorse fiscali
generate dalle rispettive comunità territoriali riuscirebbero non solo a
finanziare abbondantemente le funzioni che attualmente esercitano (insieme ai
loro enti locali), ma riuscirebbero altresì a coprire il finanziamento
di ulteriori funzioni che lo Stato dovesse trasferire loro[21].
Non per caso la linea politico-istituzionale delle suddette regioni è,
sul punto, ferma e senza tentennamenti: sanno perfettamente qual è il
loro interesse e coerentemente mirano a perseguirlo; un interesse che,
peraltro, non appare mutevole nel tempo.
Qual è invece l’interesse delle specialità
insulari? Non è del tutto corretto sostenere che avrebbero interesse a
rivendicare una specialità finanziaria “forte” e seguire,
così, la stessa linea delle regioni speciali prima ricordate. Non
bisogna dimenticare che la capacità fiscale insulare non è la
stessa delle regioni speciali settentrionali.
Si prenda ad esempio il caso della Sardegna. Questa si trova in
una condizione complessa, perché ha un interesse di breve periodo che
diverge da quello di lungo periodo. Vive, perciò, una sorta di
condizione dissociata, schizofrenica.
Nel breve periodo sicuramente avrebbe interesse a dare finalmente
realizzazione all’art. 8 dello Statuto speciale e portare a casa le
risorse aggiuntive che questo riconosce: rebus
sic stantibus basterebbero per coprire degnamente il costo delle funzioni
esercitate dalle amministrazioni sarde[22].
Inoltre, sempre rimanendo dentro la logica dell’art. 8
(indubbiamente espressiva di una specialità finanziaria
“forte”), la Sardegna in prospettiva potrebbe richiedere allo Stato
l’attribuzione di ulteriori competenze di spesa (ad esempio in materia di
finanziamento degli enti locali o del sistema universitario): ovviamente, per
coprire il costo di queste competenze ulteriori si dovrebbe pretendere
contestualmente una corrispondente quota aggiuntiva di compartecipazioni ai
tributi erariali. Quindi man mano che si acquistassero nuove funzioni, col
relativo accollo di nuove spese, si acquisterebbero pure le risorse per farvi
fronte, e tutto ciò sempre secondo la logica dell’art. 8 dello
Statuto speciale e sempre secondo la logica del principio di
territorialità (cioè, repetita
iuvant, secondo la logica della specialità finanziaria forte).
Questo nel breve e, forse, medio periodo. E nel lungo? Nel lungo
periodo, una volta ottenuta, in ipotesi, l’attribuzione dei 10/10 del
gettito fiscale prodotto in Sardegna, se si volesse il trasferimento di nuove
funzioni e quindi di nuove competenze di spesa, aggiuntive rispetto a quelle
preesistenti, sarebbe inutile e controproducente appellarsi al principio di
territorialità e di specialità finanziaria forte: giunti a questo
punto la Sardegna avrebbe bisogno, infatti, di perequazione, ossia di
trasferimenti finanziari a titolo di solidarietà. E va da sé che,
data la ridotta capacità fiscale sarda, ben presto i 10/10 sarebbero
insufficienti per coprire la spesa connessa all’eventuale trasferimento
di nuove funzioni.
In sintesi, se nel breve periodo forse può essere
conveniente improntare al principio di territorialità (e di
specialità finanziaria forte e differenziata) il regime dei rapporti
finanziari con lo Stato, nel medio e lungo periodo forse converrà
rivendicare la perequazione. E l’abilità politica
consisterà nel capire in quale momento conviene dismettere la prima
strategia per abbracciare la seconda.
9. – Conclusione
Mentre l’esperienza delle regioni speciali del nord-Italia
s’inserisce perfettamente nella tassonomia generale proposta
all’inizio di questo saggio, poiché rappresenta un esempio
perfetto di regionalismo/federalismo asimmetrico e competitivo, nel caso della
Sardegna e della Sicilia la valutazione deve essere significativamente diversa:
dal quadro generale tratteggiato risulta, infatti, che le specialità
insulari rappresentano una vera e propria anomalia rispetto ai fenomeni cui solitamente
è associato il regionalismo/federalismo differenziato o asimmetrico[23].
In definitiva, la specialità è un modello
asimmetrico-competitivo solo per tre regioni speciali su cinque. Quelle
insulari hanno finora conosciuto poca asimmetria e nessuna capacità competitiva.
Si conferma, perciò, una verità sempiterna dell’indagine
comparata: il federalismo/regionalismo differenziato (asimmetrico e
competitivo) è un lusso per comunità territoriali forti.
Abstract
In the contemporary constitutional
experiences there are two general models of federal system: the first is
cooperative, inclusive and symmetrical, whereas the second is a-symmetrical and competitive. Moving
from the perspective opened by this big dichotomy, what can we say about the
experience of regional “specialty” that characterizes the italian
constitutional order? Is it totally true that it belongs to the second one or,
perhaps, a different answer is nearer the truth?
In this essay I will offer a general
theoretical explanation of regional specialty in Italy and I will show which
features of italian special regions are related to competitive and asymmetrical
federal systems and which features, on the contrary, are connected to a
different institutional logic.